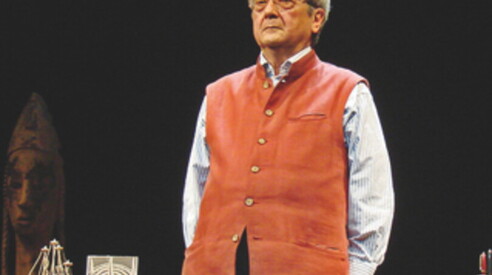
Il diavolo e l'acqua santa
A colloquio con Jacques Vergès, l'avvocato mefistofelico che porta in scena se stesso
Non ha voluto difendere Fofana, il musulmano rapitore e seviziatore dell’ebreo Ilan Halimi, ma sogna di poter difendere un giorno Osama bin Laden. Jacques Vergès ha già pronta la strategia di difesa: l’occidente, lo sfruttamento, il risentimento, ma forse è troppo sperare che accadrà. A vederlo così, mentre mangia come un commesso viaggiatore in un ristorante di Spoleto, dov’è venuto per presentare al Festival dei due mondi “Serial Plaideur”, il monologo teatrale che da un anno domina il cartellone parigino, l’avvocato più mefistofelico del mondo, difensore di un’infinta serie di indifendibili, sembra serissimo.
Di seguito riproponiamo il colloquio tra Marina Valensise e Jacques Vergès pubblicato nel Foglio del 14 luglio 2009
Non ha voluto difendere Fofana, il musulmano rapitore e seviziatore dell’ebreo Ilan Halimi, ma sogna di poter difendere un giorno Osama bin Laden. Jacques Vergès ha già pronta la strategia di difesa: l’occidente, lo sfruttamento, il risentimento, ma forse è troppo sperare che accadrà. A vederlo così, mentre mangia come un commesso viaggiatore in un ristorante di Spoleto, dov’è venuto per presentare al Festival dei due mondi “Serial Plaideur”, il monologo teatrale che da un anno domina il cartellone parigino, l’avvocato più mefistofelico del mondo, difensore di un’infinta serie di indifendibili, sembra serissimo. Ma quando parla si capisce che lo fa quasi ridendo, gli occhi a mandorla che brillano come spilli, i denti piccolissimi che s’intuiscono nella fessura della bocca senza labbra. Sebbene sia un principe del Foro cresciuto leggendo Montaigne e Voltaire e temuto per l’eloquenza infernale, Jacques Vergès è e resta un orientale. Figlio meticcio di un medico comunista, discendente da una famiglia di colonizzatori dell’Isola della Réunion, poi finito a fare il console di Francia in Thailandia; e di una istitutrice vietnamita, il cui amore gli costò l’incarico e che morì giovanissima, lasciandolo vedovo con due bambini piccoli. Vergès conserva l’indifferenza enigmatica e impassibile degli orientali, mitigata da una tranquilla ironia. “Preferisco i passionali freddi”, confessa con candore narcisista, alludendo a se stesso. E se uno gli domanda in che senso è subito accontentato: “Nel senso più pericoloso, di uno che non ha la debolezza della passione”.
Odiato e amato, temuto e blandito, osannato e osteggiato, guardato a vista e tenuto a debita distanza, Maître Vergès è accompagnato da una fama sulfurea. E’ stato il difensore di terroristi e criminali, dai militanti del Fln algerino come Djamila Bouhired, che poi divenne sua moglie, al boia nazista Klaus Barbie, il capo della Gestapo a Lione, torturatore di Jean Moulin e responsabile della deportazione di migliaia di bambini ebrei. Ha assistito, seguito, e persino coperto terroristi internazionali come il venezuelano Illich Ramirez Sanchez, in arte Carlos, sequestratore nel 1975 degli undici ministri dell’Opec a Vienna, il libanese Anis Naccache, mancato assassino del premier iraniano Shapour Bakhtiar per ordine di Khomeini, graziato da Mitterrand per intercessione dello stesso Vergès. Si è battuto per difendere con identica e fredda passione fedayn palestinesi e khmer rossi cambogiani, come Georges Ibrahim Abdallah, Wadie Haddad, George Habbash, come Pol Pot, e Khieu Samphane, suo compagno di studi. E con la stessa impassibilità ha assunto la difesa di dittatori efferati e politici sanguinari, da Omar Bongo a Abdoulaye Wade, sino a includere nella lista il serbo Slobodan Milosevic e l’iracheno Tarek Aziz. Nel suo albo d’oro manca Saddam Hussein, ma soltanto perché – dopo essere stato contattato – sono nati dissensi in seno alla famiglia del dittatore.
Insomma ha attraversato la storia del secondo Novecento trattando col distacco di un dandy un’infinità di casi umani truci, disperati. E oggi racconta come un fiume in piena, e senza alcun rimorso, una serie di aneddoti memorabili: per esempio il giorno in cui a Lione, durante il processo Barbie, accettò l’invito a cena da parte di un ebreo americano e lo sconvolse mostrandogli quant’era popolare. “Ero solo contro altri 39 avvocati. Senso massimo di euforia. Ma la gente vuole l’eroe, anche se criminale, vuole la vita vera, non l’astrazione umanitaria”. Ricorda l’ultima visita all’ex boia della Gestapo, Barbie, ormai un povero vecchio, costretto nell’infermeria del carcere con la sua camiciola: “Se la sollevò, mostrandomi il suo grosso organo. Quel hombre! gli dissi, e lui scosse il capo come per dire, non mi serve più a niente. La sera stessa morì”. Ma se uno gli obietta di aver violato la morale, di essere indifferente alle vittime del terrore, come ha fatto per esempio Gaetano Pecorella al teatro Caio Melisso, durante il dibattito seguito alla proiezione del film di Barbet Schroeder (“L’Avocat de la terreur”) Vergès diventa sferzante: “Se un pitbull divora un bambino, lo si abbatte, perché con l’animale il dialogo è impossibile. Ma con un uomo si può e si deve discutere. Se condanniamo un crimine in modo assoluto, non possiamo condannare un uomo in modo assoluto. E’ questo il paradosso dell’avvocato, che deve a tutti rispetto”.
Pur essendo un comunista rivoluzionario che in gioventù sognava di esportare la liberazione dall’Algeria alla Palestina, Vergès resta fedele al principio liberale del diritto alla difesa: “L’avvocato non deve identificarsi con il suo cliente. La mia etica è di difendere anche l’indifendibile. Sono contro il linciaggio. Il mio ruolo è far apparire la parte di umanità che esiste in ogni criminale il che non significa approvare l’omicidio, ma dimostrare che l’omicida è un uomo come un altro e può redimersi. Se avessi potuto, avrei difeso pure Hitler. Non vi interessa sapere come ha fatto a diventato Hitler?”.
Prima di essere un esperto manipolatore, Vergès è un umanista nel senso classico del detto terenziano: “Nihil humani a me alienum puto”. E’ uno che si diverte nel suo ruolo di avvocato del diavolo. Ricorda con voluttà derisoria il modo in cui un giorno apostrofò Georges Kiejman, altro grande principe del Foro francese, protagonista di una fenomenale ascesa sociale culminata come ministro di François Mitterrand. “Mio caro, tu sei passato dalla cantina al piano nobile, ma dentro un ascensore non si vive, non si mangia, non si fa l’amore. Che soddisfazione c’è a essere l’avvocato della Société des bains de mer che difende la Société des bains de boue?”. All’avvocatura, Vergès c’è arrivato per caso. All’inizio, dopo aver combattuto per tre anni fra i volontari di un generale condannato a morte, Charles de Gaulle, ed essere passato indenne attraverso la guerra di liberazione, s’era messo a studiare lingue orientali. Militante studentesco, s’era iscritto al Pcf. L’incontro con la giustizia avviene a trent’anni. “Mi affidarono la difesa d’ufficio di un teppistello e scoprii che avrei potuto ritrovarmi al suo posto”. La vocazione è nata. La guerra d’Algeria farà il resto. Quando gli avvocati del Fln vengono arrestati, Vergès si precipita ad Algeri a offrire i suoi servizi a Zohra Drif, l’eroina del commando di donne di cui fa parte anche Djamila. E’ lì che nasce “il processo di rottura” che lo renderà famoso e che consiste nel ribaltare la logica del dibattimento, mettendo i giudici sul banco degli imputati, mobilitando l’opinione per trasformare il tribunale in una tribuna. “Quando il giudice lesse la sentenza, Djamila scoppiò a ridere. Non rida, signorina, è grave una condanna a morte, disse il giudice. Ma se un condannato ride della sua condanna, vuol dire che disprezza il tribunale che ha emesso la sentenza e, anche se sbaglia, ha posto la questione sacrilega”, spiega Vergès nel corso dello spettacolo dedicato a se stesso.


Il Foglio sportivo - in corpore sano
Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo



