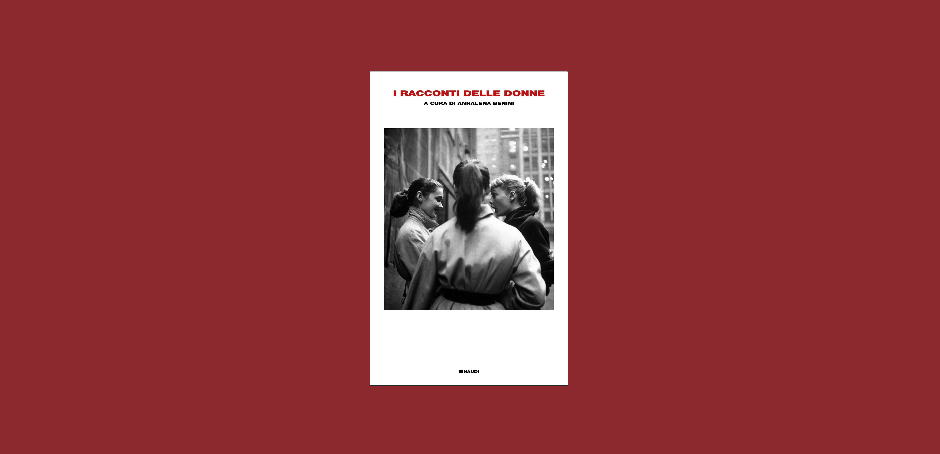Pierre-Auguste Renoir, “Jeanne Samary in abito scollato”, 1877 ( Mosca, Museo Puškin)
Il pozzo delle donne
Dove gli uomini non cadono mai. In fondo al buio c’è uno sguardo, c’è la parola femminile per narrarlo e ritrovare la luce. La festa non è finita ieri: comincia qui, nella letteratura, nei “Racconti delle donne”
Dietro i racconti che le donne fanno delle donne si nasconde sempre una scrittrice, tutta intera, che all’improvviso mostra i luoghi più segreti e sgradevoli in cui la vita l’ha trascinata, e lo fa dosando distacco e partecipazione nell’equilibrio che ha deciso essere quello giusto per la storia che sta raccontando; questo avviene in tutte le forme possibili della narrazione, che tratti di sé, di un’altra, di un personaggio immaginario o di una riflessione comune. Nei Racconti delle donne, curato da Annalena Benini per Einaudi, parlano voci diverse e potenti, spiazzanti e libere, soprattutto libere, di quella libertà che viene dalla gioia e premia il coraggio portando la luce dopo il disastro; tutte le protagoniste hanno vissuto un dislivello di potere, hanno percepito l’attimo in cui l’immagine che avevano di sé si incrinava, si spezzava modificandole per sempre, e hanno saputo raccontarne le conseguenze con onestà, dolore e a volte ironia: “Quello che mi motiva di più è scrivere di persone che sono cresciute bene eppure, sotto quella facciata, si rompono, i loro nervi si rompono”, dichiara Yasmina Reza.


Nel libro curato da Annalena Benini parlano voci potenti, spiazzanti e libere, della libertà che viene dalla gioia e premia il coraggio
In qualunque equilibrio stiano la vita e la letteratura, è sempre impossibile scrivere di ciò che non si conosce, così, più o meno nascosti, in queste venti storie non ci sono soltanto venti trame e venti stili, ma venti scrittrici tutte intere con i loro matrimoni, amanti, divorzi, figli, morti. C’è Edna O’Brian, per la quale “il sesso è uno scopo in sé” da quando l’amore ha spazzato via l’ardore religioso che era stato, a suo tempo, l’iniziazione all’amore, quando lei, ragazza di campagna, in convento si era innamorata di una suora. C’è Nora Ephron, che con grazia e lucidità constata: “Si dice che, quando è passato, il dolore si dimentica. Non sono d’accordo. Io me lo ricordo, il dolore. Quello che dimentichiamo è l’amore.” C’è Elsa Morante, che alle elementari frequentava una classe di scolarette con il grembiule bianco, tranne il figlio della maestra che era l’unico maschio e col grembiule turchino; allora lei, rancorosa e superba, si raddolciva soltanto di fronte a quel bambino che di cognome faceva Amore e portava cucita sul grembiule proprio quella parola: Amore, con la A maiuscola (“Che Dio benedica Amore. Non so come, sentivo oscuramente che costui, dal mio pianeta deserto e corrusco, mi riconduceva per via segreta alla terra”). C’è Kathryn Chetkovich, moglie di uno scrittore che diventa più famoso di lei, più famoso di tutti, e scopre che l’amore può passare attraverso l’invidia: anzi, che amore sarebbe senza un’invidia che lo spacca in due? C’è Chimamanda Ngozi Adichie, che a dieci anni in Nigeria impara, in famiglia, la parola odio e la parola amore: la prima ha le sembianze del fratello Nonso e la seconda del cugino Dozie, ma quando Nonso muore quella parola, odio odio odio, le resta dentro con ripetitività ossessiva e si lega per sempre al dolore.
C’è, in tutte le storie che Benini ha scelto, il segno di un sentimento che da ora in avanti fonderà tutte le cose, l’abbrivio buio di una poetica possibile, la pulsione che spinge una scrittrice a fermare il mondo e dire: quello che mi è successo è terribile e ridicolo, ma non importa perché io adesso sopravviverò, e sopravviverò scrivendolo. “Scrivete quello che vi toglierebbe il respiro, se non doveste scriverlo”, ammoniva Grace Paley; che si tratti di un ballo andato a male, di una relazione clandestina, di un divorzio, di un lutto o perfino di una semplice emicrania (come nel caso di Joan Didion), non esiste nulla che una donna non possa trasformare nel mezzo per accelerare il tempo e ritrovarsi l’indomani via di lì, già lontana, da un’altra parte, lasciando dietro di sé un racconto o una poesia, uniche prove che quella catastrofe sia successa davvero. Quel gioco, quel meccanismo può avvenire a patto che sulla pagina si trasferiscano, sfidando la vergogna, le contraddizioni brucianti, le umiliazioni grottesche, il fervore assoluto che quella donna, ogni volta che si è sentita messa in un angolo dagli altri o da sé stessa, ha pensato che di tanta sgarberia avrebbe potuto fare letteratura.


Non ci sono soltanto venti trame e venti stili, ma venti scrittrici tutte intere con i loro matrimoni, amanti, divorzi, figli, morti
Ogni volta che si è lasciata guardare scrivendo lei le regole, per poi osservare l’effetto che faceva sugli altri: “Comunque la metta, le mie parole producono una pausa di silenzio, quel momento delicato in cui ci si espone”, scrive Alice Munro a proposito dell’imbarazzo di definirsi scrittrice. Ogni donna che ha prodotto un racconto indelebile ha sentito, almeno una volta nella vita, che dal pozzo di cui parla Natalia Ginzburg bisognava risalire, ma non prima di averlo perlustrato a fondo, affinché nulla di ciò che aveva visto, sfruttando occhi perfezionati dall’oscurità, potesse restare non narrato: “Una cosa mi sembra ora indiscutibile; che sono finalmente arrivata in fondo al mio pozzo di petrolio e non riesco a scribacchiare abbastanza in fretta per portarlo tutto quanto alla superficie”, scrive Virginia Woolf, in preda alla smania di non poter tralasciare nemmeno una parola del buio che ha visto dentro sé. “Ogni volta che cadiamo nel pozzo noi scendiamo alle più profonde radici del nostro essere umano e nel riaffiorare portiamo in noi esperienze tali che ci permettono di comprendere tutto quello che gli uomini – i quali non cadono mai nel pozzo – non comprenderanno mai”, scrive Alba de Céspedes in risposta a Ginzburg. E’ quel gradino di differenza fra uomini e donne che va esplorato e non eluso, perché, come precisa Annalena Benini, “la differenza è interessante, viva e merita di essere raccontata”. Del resto ci vogliono molti uomini per fare una donna, di Clarice Lispector la filosofa Hélène Cixous ha dato questa definizione: “Se Kafka fosse una donna; se Rilke fosse una scrittrice brasiliana ebrea nata in Ucraina; se Rimbaud fosse stato una madre e fosse arrivato all’età di cinquant’anni.”


Tutti noi viviamo così, storditi ma intatti, menomati e arricchiti, ma non tutti sanno vederlo e raccontarlo con tanta audacia
Irriducibili e lontane dai cliché, le venti donne di questo libro amano e soffrono con intelligenza e ironia, con il corpo e la mente; diventano autentiche e forti mentre trattano l’assurdo come fosse normale e rendono indispensabili dettagli altrimenti invisibili a chiunque altro. Non basta uno sguardo straordinario per essere una scrittrice, non basta la capacità di stanare nel profondo ciò che è comune, serve talento nel raccontarlo facendo in modo che tutti, leggendolo, possano esclamare stupiti: come fa a saperlo, come fa a conoscermi, come ha fatto a guardarmi dentro così bene dal momento che è proprio quello che è successo a me. La risposta è lì, nel saper raccontare la vita “unica, selvaggia e preziosa” che Mary Oliver racchiude in un verso, nell’esergo. Quella poesia si intitola Giorno d’estate, e ogni racconto di questo libro è un lungo pomeriggio di fine giugno, una luce calda e infinita dentro cui ogni cosa è esasperata, il male fa più male e l’amore è più amore. E’ “il giorno dopo la festa” di cui parla Valeria Parrella nel racconto omonimo, in cui una cinquantenne divorziata risveglia i propri sensi flirtando col cameriere del ristorante dove va a mangiare con la madre: “Alla festa siamo buoni tutti a partecipare, ma quello che più conta è come ti senti il giorno dopo”. Il giorno della decadenza, quello ritratto nei fulminei versi di Patrizia Cavalli che chiudono il libro: “E adesso tutti mi chiamano signora. / Certo sarebbe peggio signorina”. Non c’è consapevolezza senza ironia, non c’è ironia senza disperazione: è una verità che le donne conoscono meglio degli uomini e quando hanno avuto, o si sono prese, la libertà di raccontarla l’hanno fatto senza pudore, con un’ostinazione che rastrellando il fondo tirava su tutto, dall’angoscia all’allegria, dalla sottomissione alla vendetta.


Non basta uno sguardo straordinario per essere una scrittrice. Bisogna saper raccontare la vita “unica, selvaggia e preziosa”
“Sono cresciuta in una famiglia di donne, ho visto mio padre annoiarsi ai pranzi di Natale se costretto a parlare a tavola con alcuni fidanzati di passaggio e non con noi, ho avvertito, prima confusamente e poi sempre più nitido, il movimento verso la libertà, la ricchezza, il mistero di essere una donna: mia madre e mia zia che bisbigliano in cucina e ridono, mia nonna che le guarda preoccupata e contenta dall’altra stanza, mia sorella che ha appena imparato a camminare e si aggrappa a me, io che sono ancora troppo piccola per avere accesso a quei segreti ma non c’è niente che mi interessi più al mondo”: l’introduzione di Annalena Benini è il ventunesimo racconto, moltiplica le immagini e i ricordi di chi legge preparandolo all’universo in cui sta per entrare. Penso alle mie domeniche d’infanzia, quando mia madre e le mie zie si chiudevano in una stanza e finalmente parlavano con sollievo perché era arrivato il momento delle confidenze accompagnate dal caffè e io, più piccola di loro e di tutto il mondo, spiavo quella comunità non desiderando altro che farne parte. Per molte donne è quello il momento dell’iniziazione: il rito delle più grandi che ti mostrano la società invisibile, sotterranea e solida di cui stai per far parte. Simone de Beauvoir, prosegue Benini, lo scrive nell’Età forte: “D’un tratto conobbi un gran numero di donne che avevano passato la quarantina, e che, attraverso la diversità delle loro situazioni e dei loro meriti, avevano fatta tutte quante un’identica esperienza: erano vissute come ‘esseri relativi’. Poiché io scrivevo, poiché la mia situazione era diversa dalla loro, e anche, credo, perché sapevo ascoltare, esse mi dissero molte cose; cominciai a rendermi conto delle difficoltà, delle false facilità, dei tranelli, degli ostacoli, che la maggior parte delle donne trovano sul loro cammino, e sentii anche fino a che punto esse ne fossero ad un tempo menomate e arricchite”.
Marguerite Yourcenar della sua Saffo scrive: “E’ nata in un’isola, e questo è già un inizio di solitudine”. E poi: “gli uomini della sua vita non sono stati che i gradini che ha scalato non senza sporcarsi i piedi”. Questa creatura nuda, atletica, questo astro magro e smunto dai seni tristi è la creatura più straziante dell’intera antologia e quando si suicida è “stordita, ma intatta”, come se neppure l’urto, la caduta avessero potuto intaccare la perfezione del suo marmo pallido.
Tutti noi viviamo così, storditi ma intatti, menomati e arricchiti, ma non tutti sanno vederlo e raccontarlo con tanta audacia, indicando il punto in cui abbiamo perso la competizione, vera o immaginaria, con noi stessi o con gli altri. Non tutti sanno raccontare l’imbarazzante intimità con il proprio sé come fanno le venti scrittrici che Annalena Benini ha convocato. Quella convocazione è la chiamata a una festa nella quale le donne possono incontrarsi, ballare, brillare anche quando cadono, soprattutto quando cadono, e così si sentono legittimate a esistere. Nessun altro, al di fuori di loro, può dar loro quella legittimazione; la letteratura è una delle forme in cui il riconoscimento può manifestarsi, perciò è il luogo giusto dove far cominciare la festa. Ed è il modo più veloce per saltare i convenevoli e sapere subito cosa vede, cosa pensa, come si muove nel mondo la donna di cui vogliamo sapere tutto, e chissà chi l’ha già invitata a ballare o se c’è andata da sola, perché nel tempo che serve a un uomo per prendere coraggio lei era già lì, forte e libera al centro della stanza.
Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli. “I racconti delle donne”, il libro a cura di Annalena Benini, è in libreria dal 5 marzo scorso per Einaudi (288 pp., 19,50 euro).