
Balthus, “Therese”, 1938
Racconto d'amore in purezza
Torna in libreria “Sonečka”, la poesia di Marina Cvetaeva che si fa prosa. Un commovente congedo del cuore
Nel 1937 Marina Cvetaeva ha quarantacinque anni. Ha amato, ha perso tutto, ha scritto versi straordinari, è stata danneggiata e perseguitata, è fuggita, ha vissuto insieme alle sue figlie la miseria e l’emarginazione mentre la guerra la separava dal marito; nel suo caso, la Storia ha fatto più che intrecciarsi con la vita: l’ha devastata minacciando di spazzarla via a ogni istante, mentre lei faceva dell’ostinazione e della poesia una sola forma di attaccamento all’esistenza. La rivoluzione, i tradimenti, lo spionaggio, gli omicidi, i gulag, nulla – davvero nulla – di ciò che accadde in quei decenni l’avrebbe risparmiata fino e oltre l’ultimo giorno, domenica 31 agosto del 1941, quando salirà su una sedia e appenderà una corda a una trave. Non aveva ricevuto né un sollievo né un aiuto economico dagli amici ai quali si era rivolta per comprare da mangiare, non aveva ottenuto nemmeno il posto da lavapiatti per cui aveva fatto richiesta alla mensa dell’Associazione degli scrittori. Il funerale si svolse tre giorni dopo, non ci andò nessuno e nessuno sa dove sia sepolta di preciso, in una fossa comune del cimitero di Elabuga, nel Tartastan, dove era andata a vivere insieme al figlio Mur.


La rivoluzione, i tradimenti, lo spionaggio, gli omicidi, i gulag, nulla di ciò che accadde in quei decenni l’avrebbe risparmiata
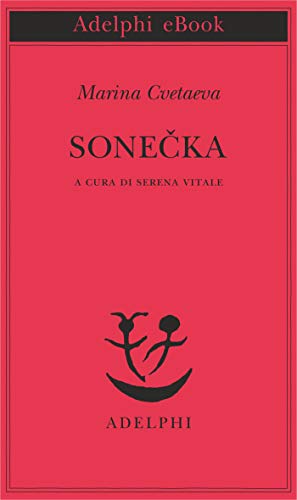 Ma nel 1937 Marina è ancora viva, sopravvissuta a molte rovine e a molti amori, sospesa e sospinta verso angoli sempre più bui, dopo aver trascorso molte notti cupe, intuitivamente consapevole che quella più cupa debba ancora venire. E’ allora che, mentre vive l’imminenza del disastro e assorbe il presagio, cambia forma alle parole. Ecco come può accadere che un poeta decida di scrivere in prosa: immerso nell’esposizione di sé, un attimo prima del rischio. “Dovete scrivere un romanzo, un vero grande romanzo. Avete spirito di osservazione, amore, siete intelligente. Dopo Tolstoj e Dostoevskij non abbiamo più veri romanzi”, le aveva detto Vjačeslav Ivanov nel 1920, e lei, irremovibile: “Sono ancora troppo giovane”. La gioventù finirà diciassette anni dopo, ma non per via dell’anagrafe; la gioventù finisce con la morte di Sof’ja Gollidej, ovvero Sonečka, l’attrice conosciuta nel 1919, in una stagione lontana, in un tempo nel quale tutto ciò che era rotto si poteva ancora aggiustare: “La mia precisione, lo so, è noiosa. Al lettore sono indifferenti le date, con le date comprometto il valore artistico del racconto. Ma per me sono essenziali e addirittura sacre, per me ogni anno, perfino ogni stagione è un volto: 1917 – Pavlik A., inverno 1918 – Jurij Z., primavera 1919 – Sonečka… Semplicemente, non riesco a vederla al di fuori di questo 9 – un doppio 1 e un doppio 9, 1 e 9 alternati… La mia precisione è la mia estrema, postuma fedeltà”.
Ma nel 1937 Marina è ancora viva, sopravvissuta a molte rovine e a molti amori, sospesa e sospinta verso angoli sempre più bui, dopo aver trascorso molte notti cupe, intuitivamente consapevole che quella più cupa debba ancora venire. E’ allora che, mentre vive l’imminenza del disastro e assorbe il presagio, cambia forma alle parole. Ecco come può accadere che un poeta decida di scrivere in prosa: immerso nell’esposizione di sé, un attimo prima del rischio. “Dovete scrivere un romanzo, un vero grande romanzo. Avete spirito di osservazione, amore, siete intelligente. Dopo Tolstoj e Dostoevskij non abbiamo più veri romanzi”, le aveva detto Vjačeslav Ivanov nel 1920, e lei, irremovibile: “Sono ancora troppo giovane”. La gioventù finirà diciassette anni dopo, ma non per via dell’anagrafe; la gioventù finisce con la morte di Sof’ja Gollidej, ovvero Sonečka, l’attrice conosciuta nel 1919, in una stagione lontana, in un tempo nel quale tutto ciò che era rotto si poteva ancora aggiustare: “La mia precisione, lo so, è noiosa. Al lettore sono indifferenti le date, con le date comprometto il valore artistico del racconto. Ma per me sono essenziali e addirittura sacre, per me ogni anno, perfino ogni stagione è un volto: 1917 – Pavlik A., inverno 1918 – Jurij Z., primavera 1919 – Sonečka… Semplicemente, non riesco a vederla al di fuori di questo 9 – un doppio 1 e un doppio 9, 1 e 9 alternati… La mia precisione è la mia estrema, postuma fedeltà”.


La gioventù di Marina finisce con la morte di Sof’ja Gollidej, l’attrice conosciuta nel 1919, in una stagione lontana
 La gioventù di Marina finisce con la perdita, nel momento in cui il sentimento trascorso non ha più altro spazio che il ricordo, e bisogna seppellire l’amore insieme a un corpo che era stato minuto, sensuale, indomabile. Quel funerale richiede la memoria, e la memoria pretende la scrittura. È Alja, la figlia di Marina, a portarle la notizia che Sof’ja non c’è più. “Per Sonečka ci voleva un poeta”, scrive allora lei, “un grande poeta, cioè: un essere umano grande quanto un poeta. Ma nella Mosca del 1919 – non ce n’erano. Non ce n’erano più – su questa terra”. Non è vero. Nel 1919 c’era sulla terra la poetessa più grande di tutti, c’era Marina Cvetaeva a guardare Sonečka Gollidej, a respirarne l’anima capricciosa fino a rendere quell’ammirazione una parte di sé. E’ così che, ventotto anni dopo, nel 1937, l’epitaffio di Sonečka diventò un romanzo splendido, disturbante come una poesia; quel romanzo, vezzosamente chiamato racconto, torna oggi in libreria per Adelphi, nella nuova traduzione di Luciana Montagnani, a cura di Serena Vitale che firma anche una postfazione.
La gioventù di Marina finisce con la perdita, nel momento in cui il sentimento trascorso non ha più altro spazio che il ricordo, e bisogna seppellire l’amore insieme a un corpo che era stato minuto, sensuale, indomabile. Quel funerale richiede la memoria, e la memoria pretende la scrittura. È Alja, la figlia di Marina, a portarle la notizia che Sof’ja non c’è più. “Per Sonečka ci voleva un poeta”, scrive allora lei, “un grande poeta, cioè: un essere umano grande quanto un poeta. Ma nella Mosca del 1919 – non ce n’erano. Non ce n’erano più – su questa terra”. Non è vero. Nel 1919 c’era sulla terra la poetessa più grande di tutti, c’era Marina Cvetaeva a guardare Sonečka Gollidej, a respirarne l’anima capricciosa fino a rendere quell’ammirazione una parte di sé. E’ così che, ventotto anni dopo, nel 1937, l’epitaffio di Sonečka diventò un romanzo splendido, disturbante come una poesia; quel romanzo, vezzosamente chiamato racconto, torna oggi in libreria per Adelphi, nella nuova traduzione di Luciana Montagnani, a cura di Serena Vitale che firma anche una postfazione.
E io rileggo Sonečka commuovendomi come quando lo lessi la prima volta, quando si chiamava Il racconto di Sonečka, era edito dalla Tartaruga e curato da Giovanna Spendel: nulla mi addolorava come non poterlo più consigliare e regalare, perché era ormai fuori commercio. Allora, al tempo della prima lettura, avevo quattro anni di più di quelli che aveva Sonečka all’epoca dei fatti, mentre oggi ne ho quattro di più di Marina quando lo scrisse: mi fermo a studiare le coincidenze e parto per un viaggio che stavolta devo percorrere all’inverso, ieri indossavo l’imprevedibilità giovane e regale dell’oggetto amato e insieme la devozione altrettanto piena di audacia dell’amante, oggi aderisco allo sguardo adulto di chi si volta e lascia andare ciò che è andato, sapendo che il rito dell’addio consiste nel rievocare per sempre ogni dettaglio.
Cvetaeva ha scritto per nascondere l’amore ed esporre il congedo dentro un libro, un luogo invincibile dove tutti avrebbero potuto vedere quanto il suo cuore era stato grande, quanto era stato forte. Quando scrive di Sonečka non è solo lei ad amarla, la amano tutti, l’assunto da cui parte è che fosse impossibile sottrarsi, perché Sof’ja Gollidej era ed è l’amore in purezza. “Quando amate, vi dimenticate mai che amate? Io – mai”, dice Sonečka, che ama Alja e Irina, le figlie di Marina, e gioca con loro in modo naturale, come dentro un quadro di famiglia, “Gallidà! Gallidà!”, la invocherà Irina, che aveva solo due anni, quando lei andrà via, chiamandola con il nomignolo con cui l’ha ribattezzata. Nel breve, intenso periodo che trascorrono vicine, Sonečka ama le bambine, ama tutto, ama la collana di coralli grossi che Marina le ha regalato: lei, che non ne ha mai avuto una, impazzisce di felicità. Sonečka ama i coralli come Marina ama lei, ma in quel regalo non c’è una congiunzione bensì la prima forma di un distacco: non bisogna mai regalare oggetti cari a persone care, la mano che glieli porge è una mano che non riesce più a trattenere né i viventi né le cose. E’ una mano che sta offrendo qualcosa in sostituzione di qualcos’altro, una mano che sta già prefigurando una partenza. E’ così che il 1919 volge alla fine, con una collana rossa, ma com’era davvero iniziato?


Marina si consegna senza resistenze, offrendo a Sof’ja il suo rossore, il suo trasporto che brucia come una vergogna
Nel 1919 Sof’ja Gollidej aveva ventidue anni e sul palcoscenico arrivava a dimostrarne dieci di meno. E’ curioso che Marina Cvetaeva, che crede nella poesia e non crede nel teatro, si consegni senza resistenze, offrendole le sue vampate, il suo rossore, il suo trasporto che brucia come una vergogna. Sonečka è l’attrice delle Notti bianche, la bizzosa, sentimentale, innamorabile, irritabile bambina che vive di diminutivi e torrenti di parole, la donna che parla anche quando piange e quando dorme, rimpiangendo di poter avere solo una voce per volta, perché non basta, non basta mai, per tutto quello che al mondo c’è da raccontare. Ecco chi è Sonečka, nelle parole di Marina Cvetaeva: “Fuoco secco, pura ispirazione, senza alcun tentativo di indorare, sperperare, realizzare. Una catastrofe senza alcun tentativo di salvarsi”. Non importa che non si siano mai baciate se non in modo familiare, per salutarsi; i baci sono, per Sof’ja Gollidej, delizia e cruccio, “Marina, pensate che Dio mi perdonerà di aver baciato tanto?”, chiede preoccupata, e poi: “Marina, non sono mai riuscita a capire (io non capisco nemmeno me stessa) come sia possibile subito dopo aver baciato – dire una preghiera. Con le stesse labbra… No, non proprio le stesse! Io, quando prego, non ho mai baciato nessuno, e quando bacio – non ho mai pregato”. Nessuno tiene il conto dei baci, nemmeno Dio; così Sonečka è perdonata per quelli che ha dato e per quelli che non ha dato, per l’eccesso di cuore e per il suo sottrarsi, anche dopo una promessa (“io bacio sempre per prima, con la stessa semplicità con cui stringo la mano – giusto un po’ più focosamente. Il fatto è che proprio non riesco ad aspettare! Poi, ogni volta: Ma chi ti obbligava a farlo? La colpa è tua!”).


Il libro è una dispersione delle ceneri, un gesto compiuto con precisione dolorosa ma anche con una vitalità piena di gratitudine
L’amore che Sonečka prova per un amante indefinito, per tutti gli amanti possibili, è un raggomitolarsi in poltrona, un rannicchiarsi per essere abbracciata, protetta da mani forti, da un altro corpo che le faccia da scudo. E’ un’invocazione, una richiesta fragile, incalzante e inappagabile, perché Sonečka non chiede per avere, chiede per essere lei a dare: “Le era stato dato tutto, tutto, per essere amata – alla follia, perdutamente, in ginocchio: il talento, l’ardore, la bellezza, l’intelligenza, un fascino indicibile, una celebrità anonima, meglio di un nome (‘quella delle Notti bianche…’) e tutto questo nelle sue mani era – polvere, perché voleva essere lei ad amare. Ed era lei che amava”. E ancora: “Voi lo sapete, Marina, quando io amo – non ho paura di niente, non sento la terra sotto i piedi! Tutti a dirmi: Ma dove vai! Ti uccideranno! Ti sparano!”. A quella stessa guerra, a farsi uccidere e sparare nell’amore, va anche Marina. Ha tre anni di più di Sonečka ma non ha nulla della piccola, della ragazzetta, non ha nessuna instabilità volubile, non è elfica, non porta con sé ombre infantili: “Nella Mosca del 1918-1919 non avevo nessuno con cui dividere ciò che dentro di me c’era di virile, di retto, di ferreo”. Nel 1919 c’era l’amore, nel 1937 c’è invece la scrittura dell’amore, diventata nel lutto il solo amore possibile; questo libro è una dispersione delle ceneri, un gesto compiuto con precisione dolorosa ma anche con una vitalità calda, piena di gratitudine, persino di allegria. Qui la scrittura di Marina Cvetaeva fa un uso spasmodico del trattino che rende ancora più eccessivo il ritmo, è eccessivo anche per la lingua russa, è un distintivo che marchia la prosa come un singhiozzo: questa sono io, questa ero io. Questo era l’amore, il mio amore. Tutto ciò che resta e per cui bisogna essere riconoscenti è quell’attimo di beatitudine che vale un’esistenza intera, è l’amore a meritare una tomba insieme a Sonečka stessa, che dopo il 1919 si è sposata, ha continuato a recitare senza troppe fortune, si è ammalata, non ha avuto coscienza di morire, è morta nel sonno (“E adesso dormo”, le sue ultime parole). Poiché Sonečka una tomba non ce l’ha, è stata cremata (“rogo” è la prima parola che Marina ha sentito su di lei, ed è anche l’ultima che di lei si può dire), allora il racconto è il luogo dove si può stare ancora insieme, solo un altro po’ prima del congedo. Così, verso tutti gli esseri umani che sono stati amati e ameranno, verso chiunque passi su questa terra, Marina Cvetaeva lancia le ceneri di Sof’ja Gollidej, “non dall’alto di una montagna, e neppure di una collina – dalla mano di una pianura oceanica”. Più volte, fra queste pagine, si avverte il rumore della voce narrante dal fondo di una conchiglia, dalla spiaggia di un oceano. E’ una voce delle sponde, una voce che recita una preghiera sensuale e sacrale, porgendo una benedizione fatta di acqua che placa, finalmente, il fuoco. Una benedizione posata su un’anima che ha lasciato questa terra e su tutti noi che possiamo conoscerla, ancora e per sempre, attraverso lo sguardo di un sentimento audace e infinito.





