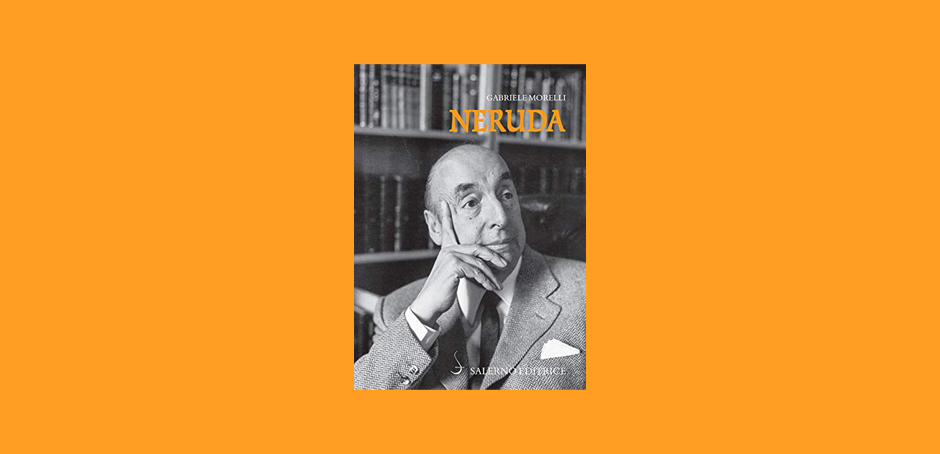Pablo Neruda (foto LaPresse)
Il fallimento di Pablo Neruda, poeta che riuscì a mutilarsi con le proprie mani
La poesia “Per uomini semplici” che lo portò a Stalin
Ricordate il famoso poeta che a Procida frequenta Massimo Troisi nel film “Il postino”? E’ Pablo Neruda. C’è qualcuno che ancora lo legge? Il poeta letto da tutti fra anni Quaranta e Cinquanta, il poeta cileno comunista, malinconico, innamorato, epico, prosastico e vicino alla vita dell’uomo comune, ma anche illimitatamente permeabile al dolore, quel poeta è oggi quasi dimenticato. Fu popolare e insieme d’avanguardia, influenzato da Walt Whitman e dal surrealismo, teorico di una poesia impura in polemica con la “poesia pura” di molto tardo simbolismo (che da noi diventò ermetismo). Raggiunse una tale fama, che il colombiano García Márquez, autore di uno dei più amati e commentati bestseller dell’ultimo mezzo secolo, Cent’anni di solitudine, alla morte di Neruda azzardò questo giudizio: “Il più grande poeta del Novecento in tutte le lingue”. Affermazione enfatica e superlativa che sembra più definire il carattere, le ambizioni dell’uomo che il valore della sua poesia. Il tedesco Enzensberger, che pure ha molto amato l’America latina, disse che lì vengono usati un po’ troppo i superlativi. Quando in gioventù andò in cerca di poeti latino-americani che lo aiutassero a liberarsi dalla tradizione tedesca, scelse di studiare il peruviano César Vallejo e Pablo Neruda. Ma al primo dedicò un saggio ammirato e partecipe (Vallejo morì a Parigi in povertà nel 1938) mentre su Neruda scrisse nel 1959 un saggio nel quale si discute soprattutto il rapporto fra poesia e politica, intitolato Il caso Neruda.
Viene subito riconosciuto a Neruda che dopo la morte di García Lorca e Vallejo, la sua è stata “la voce più potente” dell’America latina e “l’unica voce spagnola di risonanza mondiale”. Quella voce poteva essere descritta così: “A un tempo appassionata e monotona, indifferente e commossa, solitaria e distesa. Una voce elementare: simile al mare. La sua risacca, il suo respiro è ampio e inarrestabile, la sua rassegnazione è nutrita di sdegno, tenerezza e ribellione”. In una tale poesia poteva entrare di tutto: “Sudiciume, cose putrefatte, consunte, logore, rotte”. Neruda parla di natura e di povertà, nelle sue metafore si incrociano provincialismo e universalismo, quotidianità opaca, sorda, infelice e vastità cosmiche.
Gabriele Morelli, autore di un libro su Neruda appena uscito per le edizioni Salerno (315 pp., 21 euro) descrive quello delle sue prime poesie come un “universo d’acqua, alberi, insetti e oggetti di uso comune, le scarpe consunte, i vestiti logori e bagnati, immagini che restituiscono contatto e calore umano nella solitudine del vasto e desolato panorama della selva australe”.
A Madrid Neruda conobbe, all’inizio degli anni Trenta, poeti che lo accolsero fraternamente come Lorca, Rafael Alberti, Vicente Aleixandre, prima della diaspora a cui li costrinse tutti dopo la vittoria di Francisco Franco. E’ da allora che Neruda diventa uno degli scrittori di sinistra più noti e amati. Nel 1953 riceve il premio Stalin e il poeta diventa un caso discusso dalla stampa sia in America che in Europa. Ma secondo Enzensberger Neruda è stato sempre un “caso”, da quando, poeta-console andò a Rangoon, poi a Ceylon, Singapore, Giacarta e infine, per sua fortuna, a Buenos Aires. In contatto con la Spagna e negli anni della guerra civile, la poesia “impura” di Neruda diventa qualcosa di diverso: poesia politicamente engagée.
Nel 1936 spiegò in versi: “Mi chiederete: Dove sono i lillà? / E la metafisica coperta di papaveri? / E la pioggia che di continuo sferzava / le tue parole? (…) Generali, / traditori: / guardate la mia casa morta, / guardate la Spagna lacerata / (…) Venite a vedere il sangue per le strade”.
L’anno dopo, aiuta gli amici spagnoli a immigrare. Nel 1943 viene eletto senatore in Cile con l’appoggio del Partito comunista, di cui entra a far parte. Sono degli anni successivi poesie come questa: “Staliniani. Portiamo con orgoglio questo nome. / Staliniani. E’ questa la gerarchia del nostro tempo! / Lavoratori, pescatori, musicisti staliniani! / Letterati, studenti, contadini staliniani!”.
L’interpretazione, la tesi di Enzensberger per spiegare il perché un poeta come Neruda “si sia mutilato con le proprie mani” coinvolge tanto il problema sociale latino-americano che quello del rapporto tra poesia moderna e pubblico. Neruda non aveva ragioni per temere personalmente “il terrore staliniano; quello che ha fatto, lo ha fatto volontariamente”. Non aveva neppure bisogno di opportunismo, perché la sua carriera diplomatica sarebbe stata facile e promettente. In realtà, diventare comunista gli avrebbe complicato la vita. Non era neppure un uomo portato alla fede. Ma alle spalle aveva società latino-americane impoverite, strapiene di diseredati e in cui la democrazia liberale era solo fatta di parole.
Comunque, il suo problema era anche quello della situazione sociale della poesia moderna, una forma letteraria che si era allontanata dal pubblico dei lettori. Nel programma di Neruda c’era una poesia “per uomini semplici” e questa scelta era incoraggiata, sostenuta dal marxismo. Solo che il marxismo era Stalin e il pubblico degli “uomini semplici” era un pubblico che lui credette di raggiungere sacrificando la propria poesia ai lettori di fede comunista. Il risultato fu disastroso sul piano letterario, senza peraltro raggiungere un vero risultato sociale. Alla fine, il libro più letto di Neruda, in milioni di copie, restano le Venti poesie d’amore e una canzone disperata, scritte quando aveva poco più di vent’anni.