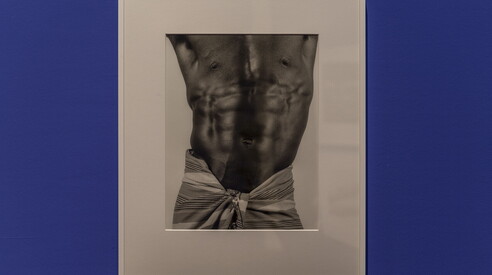Ansa
1924-2024
Cento anni senza Kafka, ma pieni del suo realismo comico
Il padre, l’autorità, lo straniero, la prigione… Eppure non era solo “lo scrittore della colpa e del vuoto”. Un’altra chiave di lettura
"Una mia grande frustrazione quando cerco di leggere Kafka con gli studenti è che è impossibile far loro capire che Kafka è comico. Né tantomeno apprezzare il modo in cui questa comicità è intimamente legata alla potenza dei suoi racconti”. Questo diceva David Foster Wallace nello scritto dall’autoironico titolo: Alcune considerazioni sulla comicità di Kafka che forse dovevano essere tagliate ulteriormente (1999). Wallace sosteneva che gran parte dell’umorismo di Kafka non è affatto sottile, o meglio è antisottile: “La comicità di Kafka dipende da una sorta di letterarizzazione radicale di verità solitamente trattate come metafore. (…) E’ sempre anche tragica, e questa tragicità è sempre anche una gioia immensa e riverente. (…) Il suo in definitiva è un umorismo religioso eroicamente sano”. La conclusione di Wallace è che le storie di Kafka sono una specie di porta che si apre verso l’esterno: e questo è il comico. Del resto Philip Roth progettava di portare Il castello di Kafka sullo schermo, interpretato da Groucho Marx. Aveva ragione: sarebbe stata la trasposizione giusta.
Questa della comicità è la chiave con la quale leggo anch’io Kafka, perché, d’istinto, così lo lessi la prima volta, rimanendone io stesso sorpreso, all’età di quattordici anni. Ricordo che mia madre, che mi aveva passato un po’ scettica la sua copia dei racconti con la copertina nera e la muraglia cinese in rosso stampata sopra, rimase assai perplessa, e forse anche un po’ preoccupata, quando mi sentì sghignazzare durante la lettura della Metamorfosi. Le mie successive, e più sistematiche, letture di Kafka mi confermarono in questa impressione. Anche perché, negli anni Ottanta, i miei frequenti soggiorni nell’Europa centrale mi fecero sentire che il mondo rappresentato da Kafka si era fatto, in quelle realtà, con gli anni, sempre più tragicomico. L’incubo grottesco del cosiddetto “socialismo reale”, grazie a lui, appariva chiaramente comico. Per molti dei miei amici a Varsavia e Praga, Kafka costituiva una lucida chiave di lettura della realtà e la proposta di un salutare e resistenziale sghignazzamento. E infatti i suoi libri erano introvabili e, in Unione Sovietica addirittura proibiti.
Il 27 e 28 maggio del 1963, nell’ottantesimo anniversario della nascita di Kafka, si tenne a Liblice, vicino a Praga, un poco ortodosso convegno di studi sulla sua opera che vide come protagonisti alcuni di quelli che sarebbero stati animatori della Primavera di Praga, e poi costretti all’esilio dopo l’invasione dei carri armati russi (Cfr. AA VV, Franz Kafka. La vita e l’opera negli studi marxisti degli anni ‘60, a c. di Saverio Vertone, De Donato, Bari 1966).
Come ha giustamente scritto in seguito Milan Kundera: “Credo che il modo, non soltanto mio, ma dei cechi in generale, di capire Kafka è sicuramente diverso da quello vostro. Per noi Kafka è uno scrittore realistico perché la sua è una visione lucida della realtà. Nessuno di noi legge i suoi libri come se fossero delle allegorie. Inoltre siamo molto più sensibili al suo humour. La specificità dello humour di Kafka è che una certa comicità accompagna l’uomo in tutte le sue azioni”.
Kafka “umorista realistico”? Ricordo che il dolce professore di Letteratura ungherese all’Università di Firenze e scrittore di teatro, Miklos Hubaj, raccontò una volta che, dopo il fallimento della rivolta di Budapest del 1956, molti intellettuali furono prelevati da casa dalla polizia, bendati e portati in camion in un viaggio di diverse ore, durante le quali tutti erano convinti che, alla fine, li avrebbe attesi la fucilazione. Quando i camion si fermarono, li fecero scendere e tolsero loro le bende, si trovarono di fronte un paesaggio montano (erano in Romania) sovrastato da un enorme castello-prigione. Fu allora che il filosofo Georgy Lukàcs disse a voce alta, provocando una liberatoria risata di tutti: “Ho sempre sostenuto che Kafka era uno scrittore astratto e piccolo borghese. Ora ho capito che era un grande scrittore realista!”.
E ricordo anche che quando, nel febbraio del 1988, vidi al Thèatre du Gymnase di Parigi, lo splendido adattamento e messa in scena del regista inglese Steven Berkoff, de La metamorfosi di Kafka, con Roman Polanski nel ruolo principale di Gregorio Samsa, Polanski, sostenne di scorgere da sempre nell’opera dello scrittore praghese una vena neanche tanto nascosta di comicità. E aggiunse: “Questa comicità sfugge completamente a uno spettatore non est europeo, abituato, o forse condannato, dalla scuola e da svariati libri, a considerare Kafka esclusivamente come lo scrittore della colpa e del vuoto”.
Ma c’è un breve racconto di Kafka, intitolato Un vecchio foglio (Ein altes Blatt), originariamente scritto e pubblicato nel 1917, che, soprattutto di questi tempi, ha qualcosa di inquietante e niente affatto comico. Kafka lo compose nel pieno della guerra che stava portando al definitivo dissolversi dell’impero austro-ungarico, in una Praga paralizzata dalla fame e dalla mancanza di carbone. Però, in una lettera al suo editore Kurt Wolff (datata 7 luglio 1917), Kafka scrisse: “In questo inverno tutto mi è stato un poco più facile. Le invio qualcosa fra gli scritti utilizzabili nati in questo periodo, 13 prose. L’insieme è assai lontano da ciò che in realtà voglio”. Queste prose confluiranno nella raccolta Un medico di campagna (Ein Landartz), pubblicata probabilmente nel 1920.
L’inizio del racconto è un’amara denuncia della situazione politica da parte dell’io narrante, un calzolaio con bottega nella piazza dove si affaccia il Palazzo dell’imperatore: “Sembra che molto sia stato trascurato nella difesa della nostra patria. Finora non ce ne siamo curati e ci siamo dedicati al nostro lavoro; ma gli eventi degli ultimi tempi ci preoccupano” (uso la traduzione di Andreina Lavagetto nel volume Franz Kafka, La metamorfosi e tutti i racconti pubblicati in vita, Feltrinelli 1991, pp. 158-160).
La piazza, improvvisamente e incomprensibilmente, è stata occupata da una folla di nomadi provenienti dal nord. Si sono accampati lì, fanno rumore e sporcano. Con loro non si può parlare perché non conoscono la “nostra lingua”. E la loro non si può dire che sia una lingua: “Fra loro si intendono come fanno i corvi. In continuazione si sente questo gridare di corvi. Il nostro modo di vivere e le nostre consuetudini sono loro altrettanto incomprensibili quanto indifferenti (…). Spesso fanno smorfie: allora gli si rovesciano gli occhi e gli esce la schiuma dalla bocca, ma con questo non vogliono dire nulla né incutere spavento; lo fanno perché è il loro modo di fare. Quello che gli serve, se lo prendono”.
Un po’ alla volta gli stranieri prendono, incontrastati, il controllo della città. ll senso di impotenza dinanzi alla loro occupazione, e alla necessità di nutrirli per tenerli buoni, cresce col procedere del racconto, fino all’episodio dell’assalto al bue vivo del macellaio che viene sbranato e divorato crudo, mentre l’Imperatore, forse, guarda mestamente dalla finestra del suo palazzo. Il finale del racconto rimane aperto, ma contiene una sorta di amara presa di coscienza della classe media: “‘Cosa accadrà?’ ci chiediamo tutti. (…) A noi artigiani e commercianti è affidata la salvezza della patria; ma noi non siamo all’altezza di un simile compito; né mai ce ne siamo vantati. Si tratta di un malinteso; e questo malinteso è la nostra rovina”.
Così, cento anni fa, Kafka descrisse perfettamente la paura dello straniero, la sua trasfigurazione in un mostro (al quale non si riconosce nemmeno il diritto ad avere una lingua umana) e il disagio e la frustrazione dei bottegai dinanzi alla latitanza dello Stato. L’uomo medio (rappresentato qui dal calzolaio e dal macellaio) soffre l’impotenza muta dell’Imperatore e desidera l’“uomo forte” che lo difenda dagli estranei e riporti la “normalità”. Il silenzio dell’Imperatore e del potere che lascia a sé stessi i cittadini, è la manifestazione e la conseguenza di ciò che, alcuni decenni prima, con l’avvento della società di massa, è accaduto quando è andata in frantumi l’autorità dei padri.
La raccolta di racconti, che contiene Un vecchio foglio, doveva, nei desideri di Kafka, essere dedicata a suo padre. Ma, proprio nell’autunno del 1919, Kafka scrisse una Lettera al padre (Brief an den Vater, trad. it. F. Kafka, Lettera al padre, Feltrinelli, 1991, pp.75-95.) che, com’è immaginabile, non venne mai consegnata al destinatario. Si tratta di un testo bellissimo e prezioso per capire come fossero i “padri patriarcali” e la crisi di un certo tipo di autorità che garantiva una certa coesione sociale. Kafka, inizialmente, descrive il padre come una specie di dio, che lo sovrasta anche dal punto di vista fisico, e gliene dà ripetutamente atto: “Tu eri per me la misura di tutte le cose”; “era già sufficiente a schiacciarmi la tua sola immagine fisica”; “come padre sei troppo forte per me”; “mi bloccano la paura di te e le sue conseguenze”. La diversità tra di loro è la fonte del dolore (“eravamo così pericolosi l’uno per l’altro”) e di una situazione insostenibile (“la sensazione di nullità che spesso mi domina ha origine in gran parte dalla tua influenza”).
Però quell’autorità, fortunatamente!, non regge più al confronto con il mondo moderno, dove un figlio, avendo la possibilità economica di studiare, si emancipa e non riesce più (nonostante gli voglia bene) a sottostare a un’autorità eccessiva e indiscutibile (“ai miei occhi hai l’aspetto enigmatico dei tiranni”). La vergogna e le umiliazioni diventano insopportabili per un figlio ormai adulto e persino la paura della violenza fisica irrilevante: “Le continue minacce produssero una sorta di indifferenza; e la certezza di non essere picchiati era diventata, col tempo, più sicura”. Caduta la maschera di un’autorità arcaica e insostenibile, agli occhi del figlio appare una figura meschina (come lo sono sempre i dittatori quando vengono detronizzati): “Cominciai ben presto a osservare e a rilevare in te alcuni lati ridicoli, li elencavo e li esasperavo”.
Il vecchio potere e la tradizionale autorità paterna appaiono ancronistici e grotteschi, ma provocano, nel vuoto che lasciano, un profondo disagio: “Avevo perso la fiducia in me stesso sostituendola con un immenso senso di colpa”. Franz Kafka vive l’inizio di un tragicomico periodo d’incertezza e immaturità che non è ancora finito. Il suo calzolaio ha paura di tutto ciò che è diverso, lo sente come una minaccia, prova fastidio per la confusione, che accresce la sua insicurezza e il suo impotente senso di colpa: sogna il ristabilimento dell’ordine e la cacciata degli stranieri, senza saperne il prezzo. C’è ancora un malinteso sul male del mondo.