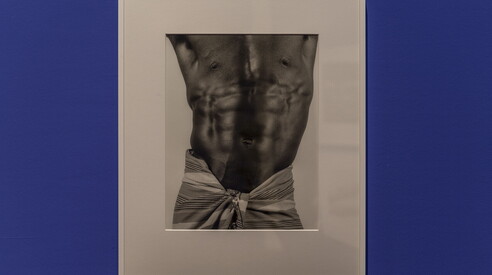Balthus, “Carte da gioco”, 1950
La carne triste. “I figli sono finiti” è l'ultimo romanzo di Walter Siti
Un vecchio e un giovane, un chiasmo di solitudini, alle prese con il sesso digitale. Augusto, professore di francese simile ad altri alter ego sitiani, e Astòre, il ragazzo che per non soffrire cerca di diventare insensibile come un robot
A Walter Siti non dispiace esibire una perentorietà da sentenza o da ultimatum. Lo si vede già dai titoli dei suoi libri. Ma quello del suo ultimo romanzo uscito ora per Rizzoli, “I figli sono finiti”, è più lapidario del solito. Potrebbe suonare un po’ come un “dopo di me il diluvio”. Senza dubbio annuncia un testo che ha davvero qualcosa di definitivo. Molti cerchi vi si chiudono. Per certi versi “I figli sono finiti” sembra quasi il seguito di un altro romanzo milanese di Siti, “Bruciare tutto” (2017). L’Astòre protagonista del libro di oggi, ventenne intelligentissimo e fragile, somiglia parecchio al bambino Andrea che spiccava nella trama di sette anni fa: come se, resuscitato dalla sua morte orribile, lo stesso personaggio avesse potuto attraversare l’adolescenza. Ma stavolta, anziché fargli incontrare un giovane prete macerato dal rimorso, l’autore gli assegna come vicino di casa un vecchio professore di francese delle superiori, il settantenne Augusto.
Il romanzo del 2017 si concludeva su una sciagura esotica, e così si apre “I figli sono finiti”: nel gennaio del 2020 Vincenzo, il marito di Augusto, annega durante un viaggio in Colombia. Il professore ne ha letteralmente il cuore spezzato: e di lì a poco gli sarà concesso un trapianto. L’incidente decreta il fallimento dell’unica famiglia che Augusto ha saputo crearsi. Simile a tanti alter ego sitiani, oltre Vincenzo ha conosciuto infatti solo fiacche relazioni di compromesso o l’abbandono a “desideri inconsulti”. Ed è a questi desideri che si riconsegna vedovo, nella sua “vecchiaia senza riparo”: rapidi accordi con sconosciuti, contatti social, ma anche un escort fisso che stabilisce una consuetudine ben nota ai lettori di Siti. Come ben nota è l’ingegnosità con cui, in ogni suo libro, Siti prova a intrecciare l’esistenza dei suoi personaggi a una realtà sociale al tempo stesso sempre più virtuale e sempre più cruda: solo che in questo caso il romanziere è preso in contropiede dalla Storia. Due mesi dopo la sepoltura di Vincenzo scoppia la pandemia Covid, nella quale al lutto per il singolo caro si sovrappone una morte di massa; e due anni dopo la guerra in Ucraina. La lunga, equivoca pace post 1945, e l’inganno ideologico di un progressismo via via più sbiadito, cioè gli orizzonti entro i quali si è svolta l’intera esistenza della generazione di Augusto, si stanno dissolvendo all’improvviso – come lui. E lui trova un piacere estremo nell’immaginare che al pianeta, per una catastrofe ecologica o bellica, toccherà la sua stessa sorte. Attende voluttuosamente che intorno le creature smettano di fiorire e riprodursi con quella serenità, precaria ma testarda, che alla sua biografia sembra negata: “I figli sono finiti” è una frase del professore, lasciata cadere già nelle prime pagine, dove si augura che la prossima pandemia stermini i giovani “o le ovaie delle donne”.
Il vecchio trova un piacere estremo nell’immaginare catastrofi. “I figli sono finiti” è l’augurio che la prossima pandemia stermini i giovani
Per reazione al dolore, questo vecchio umiliato dalla vita indossa la maschera dell’amoralità, e gode degli spettacoli in cui una forza immane si rovescia senza scampo su degli esseri inermi. In breve, tende a identificarsi con l’aggressore. Eppure neanche così può eliminare la paura atavica di non farcela. La sua soddisfazione è continuamente sul punto di trasformarsi in un magone intollerabile; e per evitarlo deve aumentare ogni volta le dosi di sadismo. Ma c’è un’eccezione. Se vedere le esistenze in fiore o quelle mutilate, specchi della sua, lo destabilizza tanto da indurlo a nascondere i singhiozzi dietro un contegno brutale, Augusto accetta invece la giovinezza e la vulnerabilità là dove sono associate a un soggetto fuori dall’ordinario. Di fronte ai “figli” eccessivamente intelligenti e nevrotici, costretti a vivere con dolorosa consapevolezza un tramonto di civiltà come se fosse un’alba, non reprime la sua commozione. Così, nel prepensionamento da Covid, nasce il rapporto con Astòre. E’ un chiasmo di solitudini. Se il vecchio non può uscire di casa, il giovane non vuole, chiuso nell’appartamento in attesa di decidere cosa fare, dopo il liceo, delle sue troppe doti e delle sue troppe ferite. Astòre è cresciuto tra due genitori benestanti e litigiosi, di cui ha imparato fin da piccolo a interpretare i dialoghi allusivi e perversi. A questa comprensione precoce ha corrisposto presto un raggelamento sentimentale: per non soffrire, il ragazzo cerca di diventare insensibile come un robot. Ma ovviamente non lo è. Oscilla tra l’ossessione per gli avveniristici destini dell’Intelligenza Artificiale, ossia per una fantascienza che considera già realtà, e una passione istintiva per le arie d’opera. Pre e post moderno, il dirimpettaio di Augusto è anche “prima e dopo il sesso”. Mentre si sottopone alla didattica scolastica a distanza, collauda a distanza l’intimità erotica. Perfetto è per lui il godimento che abolisce gli imbarazzi di un incontro tridimensionale con le coetanee: dato infatti che questi imbarazzi, al tempo di Pornhub, non sono più compensati dall’ingenua felicità della scoperta, si riducono a puro fastidio.
Astòre, mai adolescente sul serio, piuttosto terribilmente vergine e adulto insieme. “Ingenuità e intelligenza così mescolate fanno impressione”
Mai sul serio adolescente, piuttosto terribilmente vergine e insieme adulto dalla carne triste (ha visto tutti i clip), Astòre è una bestiola sofisticata e ignara. “Ingenuità e intelligenza così mescolate fanno impressione”, pensa Augusto. Tagliandosi fuori da ogni legame, il giovane si trasforma in un eremita digitale. Circondato da un mondo che promette di continuo troppi paradisi e troppi inferni, non vuole più niente, anzi vuole “il Niente”. Quando parla del futuro che vagheggia (gli organi saranno artificiali, ci si dovrà adattare a un nuovo clima, tutti capiranno che il dibattito politico e la cultura umanistica sono roba da dinosauri), Astòre si esprime con una soddisfazione per la tabula rasa analoga a quella di Augusto. Ha lo stesso bisogno di spingere alle estreme conseguenze l’invivibilità della vita, di rimuovere quei residui di sentimento che danno il magone, di cancellare la nostalgia per progetti umani che sono inscritti nel suo dna ma che sente ormai di non poter realizzare. I suoi astratti furori scaturiscono dalla necessità di sottrarsi all’imbroglio ideologico che ne ha compromesso l’infanzia. Ciò che ha irrimediabilmente deluso Astòre “non è stata la realtà ma il suo contrario, l’affannarsi di tutti a far finta di niente come se si vivesse in una bolla immaginaria”: perché ora che la bolla, con la fine del lungo benessere europeo, è infine scoppiata, si accorge che nessuno lo ha preparato ad affrontare l’arido vero.
Da età e mondi opposti, il vecchio e il giovane si trovano entrambi a gestire un lutto. E si convincono che le uniche rivoluzioni autentiche sono le mutazioni biologiche e tecnologiche. Eppure il loro trauma dipende dal fatto che le radici di tutti e due restano novecentesche. Il male, anzi, è proprio questo. Le nostre tecnologie si sono sviluppate fino a un grado di complessità non più padroneggiabile da nessuno, mentre gli esseri umani si trascinano dietro la stessa eredità psicobiologica degli antenati: e la sofferenza si alimenta di questa scissione. Allo stesso modo, nel rapporto tra Augusto e Astòre la tara si annida in un miscuglio confuso di differenze e somiglianze. I due, uniti da un comune disagio, rimangono irreparabilmente separati dai tempi della loro formazione. Con i suoi poeti francesi filtrati dalle ultime speranze di rivoluzione e con la sua mitologia omosessuale romanza, Augusto porta con sé l’eredità della letteratura come peso e via di fuga. Pur non riuscendo a credere a nulla, arranca dietro a una parodia sadomaso di Assoluto: “E’ il potere il grimaldello che conduce all’orgasmo” e “Ancora desideri, nessuna speranza” sono i suoi motti araldici. Astòre, invece, è già oltre il desiderio: e quando scopre quelli degli adulti, attribuisce l’oscenità dei loro scambi alla goffaggine di chi non sa davvero cosa vuole.
Non è forse il tema pasoliniano per eccellenza, quello della visione del proprio fantasma adolescente? Siti sta ancora lottando con il suo maestro
Resta il fatto che sia il vecchio sia il giovane, precoci e isolati, sono cresciuti nella condizione straziante di Gesù tra i dottori: genitori dei loro genitori indifesi, figli di un ambiente rispetto al quale hanno avuto strumenti più sofisticati ma da cui non avevano la maturità necessaria per affrancarsi. Il magone, e l’autodistruttività, vengono da qui. Malgrado le vocazioni di pittore e letterato, Augusto non è diventato un illustre studioso e non ha fatto mostre: in compenso “si è risparmiato il rimorso di aver tradito la propria classe d’appartenenza, e chi l’ha fatto sa quanto sia doloroso”. Quanto ad Astòre, con la sua scienza e il suo intuito sproporzionati è un mostro inerme, un Minotauro chiuso nel labirinto del web – e come ha scritto Gospodinov, cos’altro è un Minotauro se non un bambino abbandonato? Eppure, se non ha la letteratura, il ragazzo è letteratura – anzi è poesia moderna allo stato puro: nella testa gli parla una voce che scandisce versi simbolisti-avanguardisti. Ed ecco un altro cerchio che si chiude: Siti ha esordito così, come “scienziato” (della letteratura) e insieme come poeta oscuro, intrecciando un dialogo col “vecchio” Pasolini. In Astòre è impossibile non vedere la proiezione di un Walter ancora informe: e non è forse il tema pasoliniano per eccellenza, quello della visione del proprio fantasma adolescente? Così come pasoliniano, si capisce, è in “I figli sono finiti” il tema della morte inferta da uno dei “giovani infelici” che P.P.P. condannò con parole di ingiustizia sommaria e chiaroveggente.
Dunque, Siti sta ancora lottando con il suo maestro. Anche lui, come Pier Paolo, si sente escluso dalla Realtà, e la considera un Assoluto da espugnare e annientare. Solo che Pier Paolo, costitutivamente poeta, nel suo sogno lirico di onnipotenza non riesce mai davvero a oggettivarsi in un romanzo. Walter, invece, è divenuto un vero romanziere appunto perché ha saputo staccarsi da sé. Ma questa diagnosi è ancora esatta? O Siti ha atteso la gloria della vecchiaia per poter tornare, seppur obliquamente, alla poesia?
Sì, certo, “I figli sono finiti” è un romanzo; ma merita di essere guardato più da vicino. L’autore ha messo a punto una forma che della narrazione romanzesca ci restituisce una sorta di scheletro scintillante, su cui fiorisce una vegetazione di prosa sia saggistica, sia lirica e onirica. E’ il romanzo come matrice che si riproduce in automatico, per paragrafi-strofe di mezza pagina o due. Nella paratassi incalzante, ogni figura appare e sparisce senza che la vivida, ingannevole mancanza d’ordine del mondo della veglia mostri tratti troppo diversi da quelli del mondo del sogno. Tutto in questo mondo sembra franare, e tutto resta immobile. E’ per sfuggire a questa immobilità – mentre la conferma – che Siti si muove di continuo tra prospettive e su scale differenti, mantenendo però inalterata la sintassi. “Il tramestio tra cappelliere e cinture, l’ombra che si stacca da terra, l’umanità è incolpevole se vista dall’alto”: così ad esempio è descritto un decollo aereo, con una tipica sequenza in cui i brani separati dalle virgole, che stanno tutti sullo stesso piano sintattico, sono contraddetti dal dislivello straniante tra i loro rispettivi ambiti di senso. Alleata allo straniamento, la rapidità serve a far procedere la narrazione più veloce dell’incombente convenzionalità da naturalista. Ma c’è di più. Alternando stenografia saggistica e impennata lirica, Siti sfugge alla temperatura fisiologicamente tiepida del genere romanzo. Perché sa che da un secolo questo genere è mezzo morto; e che anche nella sua opera, come in quella di molti dei narratori più armati del Novecento, resta una visibile sproporzione tra l’originalità della materia psicologico-stilistica e il contenitore logoro che la ospita. Ormai manca l’attrito, lo sfondo su cui far risaltare l’oltranza della ricerca romanzesca della “vita vera”. Il nostro mondo non ha forma; tra le persone e le ideologie, non ci sono più legami privilegiati, gerarchie di senso. Al loro posto resta un babelico caos di frantumi linguistici, simbolici, affettivi. Sono i frantumi di cui Siti fissa in prosa l’effimero scintillio, al solito ansioso di acchiappare per la coda la Realtà che sembra trionfare sul momento, e di schedare gli slang destinati a cambiare nello spazio di un anno scolastico. Questo sforzo a volte si fa sentire: i dialoghi aforistici pretendono di condensare troppo lo Spirito del Tempo. Se in Balzac anche le portinaie hanno del genio, in Siti anche i depressi e i bottegai sono dei Flaiano. Ma “I figli sono finiti” è arrivato così lontano, nel collaudo dei mezzi narrativi e nella loro liquidazione, che ci si chiede se non si sia chiuso un altro cerchio: quello del romanziere Walter Siti. Ora che, come meritava, si è imposto alla letteratura italiana attraverso il genere per eccellenza popolare, l’autore non si vorrà per caso rilassare? Ora che ha conquistato un’identità pubblica sicura, e che non teme più di sprofondare nel nulla prima di essere stato riconosciuto dai suoi simili, non tornerà forse a un Io lirico, o a uno di quei generi misti che finora ha guardato con un rispetto mai esente da una certa commiserazione – perché li sa marginali e quindi, come il suo professore di francese, li vorrebbe d’istinto veder schiacciati dai linguaggi o dai media più forti? Insomma: hanno ancora bisogno, lo scrittore e i suoi alter ego, di espugnare il mondo e di nascondere la fragilità? Tutto finisce con Augusto-Astòre o tutto, con questi due nomi in A, sta per ricominciare altrove, magari in qualche libro di poesie o di saggi aforistici in cui l’autore si lascerà alle spalle la forma-romanzo come una pelle secca?