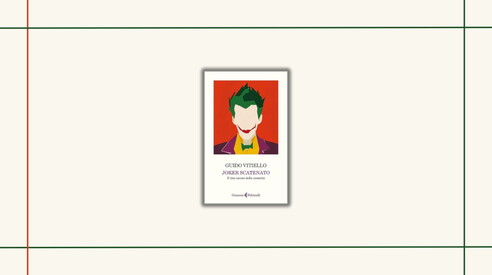Foto ANSA
Giubileo 2025
La visione delle icone in mostra a Roma spalanca un nuovo piano spazio-temporale
Una galassia di risonanze estetiche, riferimenti storici e valori spirituali quasi estranea a noi contemporanei occidentali, estesi per 18 opere che rappresentano in modo variegato le diverse espressioni artistico-religiose dell’oriente cristiano che ha raccolto la preziosa eredità delle icone dell’Impero bizantino, ormai sotto il dominio d’un credo aniconico come l’islam
Il grande telo che ricopre l’ingresso principale della borrominiana chiesa di sant’Agnese in Agone, a piazza Navona a Roma, reca il titolo “Icone di speranza”: richiamo ai passanti a entrare nella sacrestia per respirare un’aria diversa, percepibile appieno però solo se si attiva il “secondo polmone” di wojtylana memoria.
Perché per afferrare il senso dei 18 pezzi che circondano il visitatore inoltratosi, come nell’armadio di C. S. Lewis in "Narnia", in una dimensione altra, occorrerebbe avere consuetudine con una galassia di risonanze estetiche, riferimenti storici e valori spirituali perlopiù estranea a noi contemporanei occidentali, imprigionati nell’eterno presente del “qui e ora”, mentre la visione di queste icone spalanca un piano spazio-temporale del “lì e allora”. Anche se “l’allora” è meno lontano di quel che si possa credere: si tratta infatti di icone postbizantine, nate cioè dopo il grande crollo del 1453, la fine dell’Impero romano d’oriente, culla della civiltà bizantina, di cui l’icona è stata uno dei frutti più drammaticamente meravigliosi.
Se oggi queste opere si mostrano davanti ai nostri occhi è perché le loro antenate sono sopravvissute a una lunga e furiosa guerra, fatta di morti, incarcerati, esiliati, vessati e scomunicati, che era anche uno scontro radicale tra Gottanschauungen da cui discendevano Menschanschauungen e di conseguenza Weltanschauungen opposte ma presenti nello stesso corpus ecclesiale; una guerra civile cristiana e allo stesso tempo un faticoso processo di chiarificazione di fede a colpi di editti imperiali e di concili. Tutto ruotava attorno alle ragioni che legittimavano oppure vietavano la raffigurazione di Cristo (e per estensione della Madonna, degli apostoli e dei santi): da una parte il divieto veterotestamentario contro l’idolatria, rafforzato dalla circostante pressione islamizzante che irrigidiva la trascendenza divina, dall’altra la scelta di Dio di incarnarsi in Gesù Cristo, di rendersi consustanziale all’uomo, rafforzata dalla diffusa prassi popolare di venerare immagini. Prevalse quest’ultima opzione: “Se l’arte non può rappresentare Cristo vuol dire che Dio non si è incarnato”, fu la lapidaria sintesi di Teodoro Studita.
Ma non si creda che il tema “icone” si sia fossilizzato nei secoli addietro e poi sia stato ricoperto dalla polvere della storia. Due nomi-numi dell’arte del Novecento: Henri Matisse, dopo il suo viaggio in Russia nel 1911 disse che le icone russe, che lo attiravano in quanto arte primitiva, autentica, sorgiva, avevano soppiantato la sua dichiarata predilezione per Fra’ Angelico – non ancora Beato – e nei giorni che trascorse a Mosca fece impazzire la sua guida per visitare ogni monastero e ogni chiesa dove ci fossero icone, restandone folgorato. L’uso simbolico del colore, la bidimensionalità, l’assenza di prospettiva e di ombra, la loro natura rivelativa e non narrativa, lo segnarono profondamente, sino alla fine. Andy Warhol dal canto suo, di famiglia cattolica di rito bizantino dell’est europeo, frequentava a Pittsburgh la chiesa di San Giovanni Crisostomo, dotata di una grande iconostasi affollata di icone; e non si fa fatica a riconoscere nei suoi celebri ritratti l’impronta di una profana liturgia pop.
La mostra, pensata in occasione del Giubileo, curata da Anna Pizzamano e Pietro Beresh, presenta icone perlopiù donate ai Pontefici da parte di statisti in visita, entrate poi nel patrimonio dei Musei Vaticani, attualmente diretti da Barbara Jatta, figlia della nota iconografa e restauratrice di icone Maria Cristina Busiri Vici, nonché rampolla d’una nobile famiglia russa espatriata alla caduta dello zar, nella cui corte orbitava (vedi i due libri della saga biografica scritti da Alessandra Jatta per Voland). Le icone esposte rappresentano in modo variegato le diverse espressioni artistico-religiose dell’oriente cristiano, non solo russo, che ha raccolto, sviluppando anche nuovi motivi, la preziosa eredità delle icone dell’Impero bizantino ormai sotto il dominio d’un credo aniconico come l’islam.
C’è una bella icona di scuola greco-veneta con la Fuga in Egitto della Sacra famiglia e Maria che in groppa a un asino prova ad allattare Gesù (XVII sec.), una curiosa di fine Ottocento, mai esposta finora, con 144 immagini della Madonna con Bambino, donata a Giovanni Paolo II nel 1993 dal premier libanese Rafik Hariri, poi assassinato, e ci sono due icone affiancate, russa e ucraina, un san Vladimiro e una Vergine Odigitria, che al cuore di chi guarda paiono entrambe ammonire: questa sanguinosa discordia tra popoli battezzati nel Giordano russo-ucraino, il fiume Dnepr, ha un che di particolarmente sacrilego.