
il libro
La cortina di vetro
L’Unione sovietica è inciampata in una foresta in Bielorussia, dove Putin oggi parcheggia le sue armi contro Kyiv
Pubblichiamo un estratto di “La cortina di vetro”. Il libro di Micol Flammini, edito da Mondadori, racconta i personaggi, le paure, le storie che negli ultimi trent’anni hanno modellato le scelte dei paesi vissuti nell’orbita sovietica, i nuovi confini, il loro rapporto con Mosca e con l’occidente e le loro lotte per la democrazia, antiche e recenti, che nel caso dell’Ucraina sono diventate una questione di vita o di morte. In libreria dal 14 marzo.
L’Unione sovietica è caduta in Bielorussia, nella repubblica socialista che meno, tra quelle affacciate a Occidente, nutriva spinte indipendentiste e che, tutto sommato, avrebbe anche lasciato le cose come stavano. Da un lato c’erano i baltici, che non avevano mai sopportato l’Urss, dall’altro l’Ucraina, che aveva iniziato a cercare la strada per l’indipendenza. Dalle repubbliche limitrofe soffiava aria di cambiamento, in Bielorussia, invece, c’era voglia di conservazione. Nel 1991 Stanislau Shushkevihc, un professore di fisica più dedito ai laboratori che alla politica, era da poco diventato presidente del Soviet supremo della Bielorussia quando il 7 dicembre decise di organizzare una battuta di caccia nella ricca foresta di Belaveža.
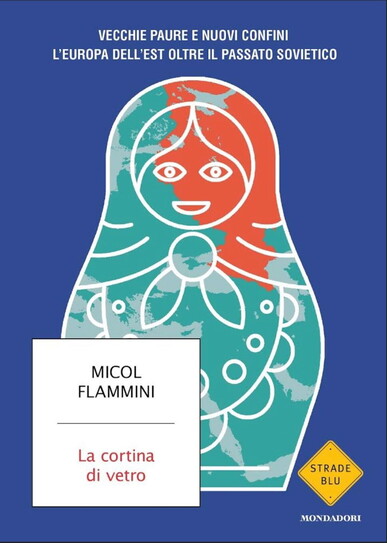
Shushkevich invitò il presidente del Soviet supremo della Russia, Boris Eltsin, e quello del Soviet supremo dell’Ucraina, Leonid Kravchuk, per parlare di consegne di petrolio e di gas. Il conto alla rovescia per il collasso dell’Urss era già iniziato e il leader bielorusso voleva assicurarsi che per l’inverno i suoi cittadini non avrebbero patito il freddo né avrebbero dovuto far fronte a una crisi energetica (la dipendenza della Bielorussia dalle fonti energetiche di Mosca non è mai finita ed è ancora al centro dei rapporti tra Aleksandr Lukashenka e Vladimir Putin). Boris Eltsin amava molto la natura e le battute di caccia, e quella di Belaveža è un’antica foresta vergine dagli scorci meravigliosi, che la Bielorussia condivide con la Polonia, dove prende il nome di Bialowieza; così Shushkevich pensò che tra quei paesaggi incontaminati avrebbe avuto maggiori opportunità di ottenere dal presidente russo un buon accordo. Non aveva però previsto che invece sarebbero finiti a parlare d’altro: del piano di Michail Gorbaciov per riformare l’Unione Sovietica.
Il presidente dell’Urss era sempre più debole, ma non rinunciava all’idea di poter ancora salvare il progetto sovietico facendo confluire tutte le repubbliche, a eccezione di Lituania, Lettonia ed Estonia, in una nuova federazione amministrata in modo più centralizzato e riformata attraverso un piano di norme che ne favorissero la trasparenza e la democratizzazione. Il problema era che soltanto il presidente bielorusso e il presidente kazako Nursultan Nazarbaev appoggiavano il progetto. I leader delle altre repubbliche caldeggiavano già l’indipendenza e lo stesso Kravchuk si era fatto promotore di un referendum per sancire l’uscita dell’Ucraina dall’Unione Sovietica che ebbe un successo straordinario e fu approvato anche nella regione orientale del Donbas e nella penisola di Crimea, abitate da una popolazione in maggior parte russofona. Kravchuk non voleva quindi sentir parlare di un’Unione riformata o più centralizzata e a Belaveža Eltsin fece capire che non sarebbe stato possibile seguire un piano che non includesse l’Ucraina, quindi bisognava trovare una soluzione alternativa.
La battuta di caccia si trasformò in una riunione serratissima. I consiglieri che avevano accompagnato i tre presidenti e pensavano di dover parlare di gas e petrolio si trovarono invece a cercare soluzioni per ridisegnare il mondo. Per Eltsin, l’importante era trovare una nuova forma di coabitazione, voleva evitare che il legame tra la Russia e le altre repubbliche venisse reciso per sempre. Stettero in piedi tutta la notte e alle prime luci dell’alba dell’8 dicembre, nella sala del biliardo della dacia del presidente-fisico Shushkevich, le tre delegazioni stesero la bozza definitiva dell’accordo di Belaveža. Il patto, che andava bene a tutti tranne che a Gorbaciov, decretava la trasformazione dell’Urss nella Csi, Comunità degli Stati indipendenti (fu Kravchuk a imporsi affinché non comparisse più la parola “unione”). La sede della nuova alleanza di paesi sovrani che prevedeva una collaborazione in campo politico, economico e militare sarebbe stata la capitale bielorussa Minsk.
L’Unione Sovietica cessava di esistere. Il 25 dicembre 1991 Gorbaciov si dimise e la vita dei nuovi Stati era ancora tutta da definire. Dopo quella battuta di caccia Šuškevičc era diventato non soltanto il primo presidente della Bielorussia indipendente, ma anche il primo presidente di uno Stato mai esistito fino ad allora. Nella storia il territorio pianeggiante della Bielorussia si è prestato a incursioni di vari nemici e imperi, è stato annesso e attaccato da più parti e quando nel 1918 venne proclamata la creazione della Repubblica popolare della Bielorussia, l’esperienza fu breve e terminò un anno dopo con l’arrivo dell’Armata Rossa e la fondazione della Repubblica socialista sovietica bielorussa. (...)
Nonostante la storia avesse dimostrato il fallimento del progetto sovietico, a Minsk c’era ancora chi pensava di poterlo rianimare.
Senza rancori o grandi desideri di rivoluzionare il sistema del suo paese, Shushkevich continuò a mantenere un buon rapporto con la Russia di Eltsin, che aveva sempre reputato un buon amico e dal quale continuava a dipendere per le forniture energetiche. Fino all’ultimo, Shushkevich fu uno dei pochi che continuarono a difendere l’eredità dell’ex presidente russo, a definirlo un uomo dotato di una visione, un riformatore; certo con il vizio dell’alcol, ma vittima del giudizio troppo severo dei politici occidentali, i quali da una personalità di Stato si aspettavano un atteggiamento più istituzionale. Traghettare la Bielorussia fuori dall’Unione Sovietica non era un compito facile, anche perché la popolazione non era ostile al passato, non conservava un ricordo negativo dei tempi dell’Urss e non aveva capito fino in fondo che motivo ci fosse per abbatterla. Così Shushkevich decise di non togliere al paese quella patina sovietica, di lasciare alcune cose immutate, di rendere il cambiamento quasi impercettibile.
Non c’era bisogno di demolire palazzi e statue, di calpestare bandiere. Ancora oggi, tra i popoli dell’ex blocco, i bielorussi sono i meno critici, e a Minsk, con le sue strade enormi, geometriche e sconfinate dove il tempo sembra essere rimasto immobile, in piazza Indipendenza è ancora presente la statua di Lenin. Shushkevich non cambiò nome neppure alla principale agenzia dei servizi segreti, che ancora oggi in Bielorussia si chiama Kgb e ha la sede nello stesso palazzo dei tempi sovietici, tenuto d’occhio dal busto di Feliks Dzeržinskij, fondatore e direttore della Ceka, la prima polizia sovietica ritenuta colpevole di una persecuzione brutale e sommaria dei nemici politici. In tutti gli altri paesi ex sovietici il nome Dzeržinskij fa tremare, in Bielorussia no. (...)
In una cosa, però, Shushkevich decise di dare retta alla maggiore forza d’opposizione anticomunista, il Fronte popolare bielorusso: cambiò la bandiera e il simbolo nazionale. La bandiera della Bielorussia sovietica era formata da due strisce orizzontali, una rossa più grande e una verde più piccola, e da un fregio laterale. Al suo posto venne adottata quella fugacemente utilizzata dal paese dopo la prima guerra mondiale, costituita da tre strisce orizzontali bianca-rossa-bianca. Come simbolo, al posto dei fasci di grano con al centro la falce e il martello sormontati da una stella, venne adottata la “Pahonia”, un cavaliere armato di spada a cavallo. La bandiera e il simbolo sono importanti per capire anche la Bielorussia di oggi e Aleksandr Lukashenka, l’uomo che, dopo aver fatto carriera come direttore di un sovchoz, domina la scena politica del paese dal 1994.
I sovchoz erano un tipo di azienda agricola interamente statale, nella quale i contadini, sovchozniki, prendevano un salario fisso e davano l’intero raccolto allo Stato. Di questa sua gestione Lukashenka fece un argomento propagandistico molto forte in politica, convinto che se era stato in grado di dirigere un sovchoz, prendere in mano le redini della Bielorussia non sarebbe stato così diverso. E siccome i bielorussi non avevano una concezione negativa di queste strutture, gli credettero. In qualsiasi altro paese posto lungo il confine occidentale dell’Urss, invece, sarebbe stata una credenziale inaccettabile per aspirare alla presidenza. Lukashenka entrò in Parlamento nel 1990, lo stesso anno di Shushkevich. Dalla sua aveva la giovane età, trentasei anni, e il fatto di essere collocato a capo di un comitato anticorruzione, parola che dalla caduta dell’Urss cominciò a diventare importantissima in tutti gli ex paesi satelliti. Lukashenka approfittò della sua posizione per mettere sottosopra le istituzioni che si stavano formando e soprattutto per muovere accuse di appropriazione indebita contro Shushkevich, che fu costretto a dimettersi. Le accuse non vennero mai provate, ma alle elezioni che si tennero nel 1994 l’uomo del sovchoz si candidò e vinse.
Shushkevich, invece, dopo aver subito una campagna di demonizzazione, ottenne soltanto il 9,9 per cento dei voti. (...) Demonizzare Shushkevich era per Lukashenka un modo per assicurare che lui avrebbe fatto di meglio: avrebbe ridato ai bielorussi l’Unione Sovietica, quella vera. Arrivato alla presidenza, decise di proporre un referendum per cambiare di nuovo stemma e bandiera e per consolidare il proprio potere, trasformando così la Bielorussia in una dittatura. Cercò di centralizzare l’economia del paese, proprio come fosse un sovchoz, elevando a motivo di orgoglio nazionale la produzione e l’esportazione dei trattori a quattro ruote Belarus, che divennero un punto fermo dell’economia bielorussa e un simbolo del potere di Lukashenka, che ne regalò uno a Putin in occasione del suo settantesimo compleanno.
Da quando fu eletto, Lukashenka lavorò al progetto di riunificare Bielorussia, Russia e Ucraina all’interno di una nuova entità statale sul modello sovietico, credendoci più di Mosca e sicuramente più di Kyiv, che invece non voleva saperne. Lo sviluppo più importante di questo programma consiste in un accordo firmato da lui e da Eltsin per la creazione di una federazione con la Russia che non si realizzò mai, ma che, secondo Lukashenka, avrebbe dovuto essere a guida bielorussa, perché soltanto Minsk era rimasta fedele ai principi dell’Urss. Per un periodo abbastanza lungo, sul piano economico la Bielorussia risultò essere la più sana delle ex repubbliche socialiste sovietiche, più sana anche della Russia. E il segreto stava soprattutto nel non aver mai davvero tentato di aprire la sua economia: per anni il prodotto interno lordo di Minsk è stato il doppio rispetto a quello di Ucraina o Georgia, che invece stavano sperimentando l’economia di mercato.
La Bielorussia aveva mantenuto la centralizzazione mentre gli altri, privatizzando le aziende statali, avevano creato le premesse per un pericoloso sistema oligarchico. Inoltre, rispetto alle altre nazioni sovietiche, Minsk non ha mai davvero tentato di staccarsi da Mosca, dimostrando una fedeltà che le ha consentito di godere delle risorse energetiche russe a prezzo scontatissimo. Con il passare del tempo, però, la fedeltà al tabù del capitalismo ha reso l’economia della Bielorussia stagnante e sempre più dipendente dalla Russia. Gli occhi dei bielorussi hanno così cominciato ad aprirsi su cosa significasse vivere in uno Stato rimasto indietro, più povero dei suoi vicini, anche di quelli ex sovietici, e su che senso avesse fare finta che l’Urss fosse ancora in piedi. La situazione si è aggravata con l’arrivo della pandemia, quando Lukashenka non ha voluto prendere decisioni che rischiassero di risultare impopolari: non ha introdotto alcun lockdown, non ha imposto l’uso di mascherine e consigliava di curare la malattia con sauna, lavoro sui trattori – l’orgoglio nazionale – e vodka. La Bielorussia è rimasta un’enclave sovietica ai confini dell’Europa con un sistema politico ed economico farraginoso e poco riformato, che ha dato a Minsk un periodo di crescita e di stabilità, ma soprattutto di dipendenza dal Cremlino di Vladimir Putin (...).
In Bielorussia il russo è la lingua ufficiale, nessuno ha mai sentito la necessità di rinvigorire il bielorusso, che esiste ma è usato da una minoranza della popolazione. Per le strade si parla in russo, nelle scuole si insegna in russo, la stampa è in russo, e nessuno rivendica l’uso della lingua bielorussa come elemento nazionalistico. Il sogno originario di Lukashenka, quando fece dimettere Shushkevich e iniziò a progettare la sua scalata, era quello di ricostituire un’Unione Sovietica in piccolo ma che avesse come centro Minsk. La cosa gli sembrava quasi probabile con Eltsin, del quale aveva poca stima, tuttavia svanì con l’arrivo di Vladimir Putin. Il presidente russo apprezzava molte cose di Lukashenka, ma soprattutto il fatto che non avesse mai voltato le spalle all’Unione Sovietica, neppure all’inizio della carriera politica, quando il suo partito, Comunisti per la democrazia, fu l’unico a votare contro l’accordo di Belaveža nel Parlamento di Minsk. Inoltre, in lui Putin ammirava la capacità di rimanere al potere, di aver fatto della Bielorussia un paese stabile, non come gli altri Stati ex sovietici affetti da continui tentativi di rivoluzione. Minsk era la purezza e agli occhi di Putin, arrivato alla presidenza quasi sei anni dopo, Lukashenka costituiva a suo modo un esempio. Doveva prendere lezioni dall’uomo che si era definito “l’ultimo dittatore d’Europa” e, dicono i bielorussi, anche la passione per l’hockey di Putin è nata per emulare Lukashenka. Non si sa quanto sia vero, ma sicuramente durante le partite a hockey i due hanno trovato un modo di intendersi e i loro scambi sul ghiaccio sono utili a capire come sono cambiate le dinamiche reciproche: da partite giocate regolarmente, lasciando alla bravura o alla sorte la vittoria, si è arrivati a una competizione che non ammette altro vincitore se non Vladimir Putin.
Se inizialmente il capo del Cremlino poteva nutrire una qualche stima nei confronti del longevo dittatore, con il tempo ha iniziato a ritenerlo un partner inaffidabile e un capo di Stato goffo e ingrato, al quale bisognava costantemente prestare soccorso. Quando Putin arrivò al Cremlino, Lukashenka aveva già firmato con Eltsin il trattato fondativo di un’unione tra Russia e Bielorussia che prevedeva una cooperazione economica, politica, commerciale e militare, e l’apertura delle frontiere. Presto il dittatore bielorusso si accorse che trattare con Putin non era come trattare con Eltsin. Il nuovo presidente del Cremlino aveva capito molto bene quanto Lukashenka avesse disperatamente bisogno di Mosca. Lukashenka, dal canto suo, ha trascorso anni a cercare di dimostrare il contrario, che era lui il vero sovietico e non il capo del Cremlino, a rassicurare i suoi concittadini che il loro modello sarebbe prevalso e che, anzi, il vero centro della fedeltà al passato era Minsk e non Mosca. Ne era davvero convinto, ma come aveva reso l’economia della Bielorussia dipendente dal Cremlino, aveva legato a Putin anche il suo destino politico.






