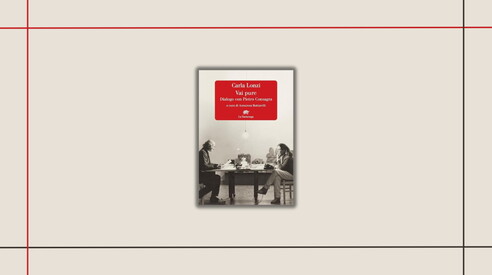Automat (Tavola calda), opera di Edward Hopper
Jean Rhys e il dolore dolcissimo
Buongiorno, mezzanotte! Visto che il mattino non mi ha voluta
Quando esco in place de l’Odéon mi sento felice, perché ho i capelli nuovi, il cappello nuovo, perché ho fatto una lauta cena, per il vino, la fine e il caffè, e perché sento l’odore che ha Parigi di notte. Questa sera non andrò in nessun orrendo bar, no, no, voglio musica e gente che balla. Ma dove vado, da sola? Bene, un altro bicchiere, e ci penso sopra.
Jean Rhys, “Buongiorno, mezzanotte”, (Adelphi)
Questo bellissimo, disarmato romanzo uscì per la prima volta nel 1939, quando Jean Rhys aveva quarantanove anni. Poco dopo lei scomparve, e molto tempo dopo venne ritrovata: stava scrivendo Il grande mare dei sargassi (pubblicato sempre da Adelphi) e considerato il suo capolavoro. Morì alcolizzata nel 1974, dopo aver raccontato meravigliosamente bene il destino non luminoso delle ragazze come lei. Era nata nei Caraibi, era bella, aveva un accento caraibico troppo forte, voleva fare l’attrice o la ballerina, non ci riuscì, si sposò molte volte, sbagliò spesso, scrisse tanto.
Chissà se ha applicato alla sua vita quella stessa voluttà e ironia nella sfortuna e nella speranzosa miseria che ha messo nei suoi libri. Quella specie di allegria sotterranea, dentro ogni disgrazia, la capacità di ridere in faccia, ma con dolcezza, a quelli con le vite perfette, le case perfette, le serate rispettabili. Jean Rhys racconta in questo romanzo le giornate a volte non rispettabili, ma soprattutto solitarie, di Sasha, che si sforza di non piangere in pubblico, né a Londra né a Parigi, che divide i bar in: neutri e ostili. In quelli ostili non può quasi più entrare, in quelli ostili c’è sempre qualcuno che le dice cose terribili, donne che ridono di lei e dell’inadeguatezza che indossa.
“Per favore, vi prego, monsieur e madame, signore, signora e signorina, ce la sto mettendo tutta per essere come voi. Non ci riesco e lo so. Ma ce la metto tutta. Tre ore per scegliere un cappello; a ogni risveglio, un’ora e mezzo per cercare di avere l’aspetto che hanno tutti gli altri. Ogni parola che dico ha una catena alla caviglia, ogni pensiero è gravato da grossi pesi”. Le catene delle nostre parole, della timidezza e del dolore. Sasha dice a se stessa davanti allo specchio, mentre piange: “Nessuno potrebbe indovinare che ci sono stata dentro fino al collo”. E invece lo immaginano tutti, gli altri sentono sempre quando si è rischiato di sprofondare davvero.
In questo romanzo ci sono atmosfere e autoironia e la soffusa disperazione che avevamo trovato nella raccolta di racconti Io una volta abitavo qui (Adelphi), il dolore gentile in cui la tragedia e la commedia si tengono la mano. Sasha si tinge i capelli, ha difficoltà a spiegare al parrucchiere quello che vuole, difficoltà a farsi prendere in considerazione, difficoltà a non suscitare compassione o derisione. Ma una volta era forte. “Ma l’ho mai amato, io? E lui, mi ha mai amata? Non lo so. So solo che fu dopo di ciò che cominciai ad andare in pezzi. Non subito, certo. Prima è successo questo, poi quell’altro…”. E’ successa una cosa terribile, che Sasha affronta con la stessa affranta dolcezza delle sue giornate in vestaglia: fissare il soffitto e bere per fare tacere la maledetta voce dentro la testa. E poi, a volte, invece, uscire sul pianerottolo e sentire di avere di nuovo tutto: l’amore, la giovinezza, la primavera, la felicità. Tutto quello che lei credeva di avere perduto.