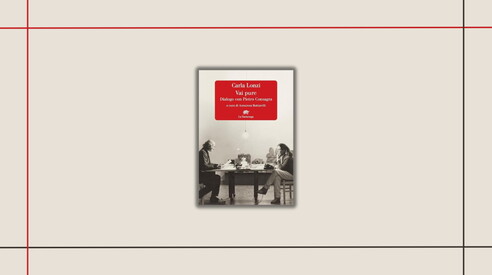Foto Ansa
Lettere rubate
Le giovani donne di Han Kang, travolte dal rifiuto di sé, sognano la rinascita (o la fine)
Nessuno sembra capace di parole di conforto, o di uno slancio vitale che sposti il dolore. Leggere “Convalescenza” significa entrare in un mondo inquietante e possibile
Non riuscivi a capire perché lei fosse invidiosa di tutti i tuoi difetti. Era invidiosa di te perché sei semplice e ostinata, perché avevi scelto una facoltà che non sceglieva nessuno, perché a trent’anni non avevi ancora avuto una storia d’amore decente, perché non andando d’accordo con i vostri genitori, non ricevevi nessun vero aiuto finanziario da loro, e perché conducevi una vita instabile, pagando ancora, alla tua età, un affitto mensile per il tuo monolocale.
Han Kang, “Convalescenza”
(Adelphi)
Le giovani donne di queste storie provano orrore per se stesse. Si rifiutano e rifiutano il mondo. Non è stato sempre così, ci sono stati anche giorni lievi e pieni di speranza, giorni con sorrisi radiosi, ma adesso la vita è diventata velenosa. C’è qualcosa di intossicante nell’aria, nelle persone intorno, nell’incomprensione che diventa solitudine malefica. Nessuno sembra capace di parole di conforto, o di uno slancio vitale che sposti il dolore. Leggere “Convalescenza”, che è uscito in Corea nel 2013, e poi “Il frutto della mia donna” (del 1997, è probabilmente il nucleo originario del romanzo “La vegetariana”) significa entrare in un mondo inquietante e possibile. Possibile anche quando il corpo della donna, prima ricoperto di lividi, poi sempre più sofferente, emaciato e senza voce si trasforma in una pianta da cui sbocciano fiori di un rosso scuro, e poi frutti minuscoli di un verde giallognolo. “Un giorno te lo chiedesti. Ti chiedesti che cosa fosse andato storto e dove”. Per tutto il tempo, dentro questo lento sfacelo accarezzato dalla lingua scarna di Han Kang, ci si chiede che cosa sia andato storto. Dove sia la luce, perché il marito di questa giovane donna appassita non sia in grado di rispondere alle sue richieste d’aiuto. Lui non la accompagna nemmeno dal medico, resta in silenzio a contemplare l’orrore della decadenza, e a lei che gli dice: “Questa non è vita, le assomiglia solo”, risponde con rabbia e violenza. Vuole tenersi stretta quella assurda, mefitica felicità che sembra una morte, non gli importa che lei si senta soffocare, vuole tornare ogni sera nell’appartamento in cui ogni pianta si riduce a terriccio rinsecchito e trovarla lì, emaciata e muta. Perché accade tutto questo? Perché si prega un dio, qualunque dio, di non guarire, ma di arrivare a invocare che questo dolore aumenti e cancelli tutto? Questo autoannientamento, questo addio alla cura di sé, questa perdita dell’istinto di salvezza, sembrano nascere sempre da una delusione. Qualcosa che è andato storto, appunto, e ha avvelenato l’aria, l’acqua, il nutrimento. La delusione che nasce a causa degli esseri umani, quando la mancanza d’amore li inaridisce, li svuota. Queste donne desiderano scomparire, o almeno trasformarsi, perché gli esseri umani le hanno deluse, e quindi il mondo le ha deluse, o perché loro stesse hanno perso la presa sull’esistenza. “Da che cosa cercavo di scappare, che cosa mi affliggeva al punto da farmi desiderare di fuggire dall’altra parte del mondo? E che cosa mi tratteneva, impastoiandomi, paralizzandomi?”. Han Kang ha una scrittura così reale, anche quando affronta l’impossibile, che l’angoscia che insinua non viene liberata dal fantastico, ma rimane addosso, e germoglia.