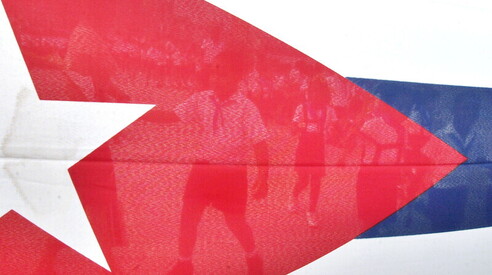Claudio Ranieri (Ansa)
Una vita da allenatore
Le opere e i giorni di Claudio Ranieri. L'addio al calcio durerà?
Gli piacevano i matti e gli irregolari quelli che non gli somigliavano. Pensare che un signore secondo per panchine solo ad Arsene Wenger, un galantuomo che non ha mai confuso gentilezza e debolezza, carisma e piazzata, tra qualche mese a bordo campo non sia più, rende tutti un po' più tristi
Come un cane nella pioggia quest’uomo se ne va / Voglia di piangere è poco, davanti a tutta questa libertà (Francesco De Gregori).
All’oratorio, tanti anni fa, il signor Ranieri si piegava al sacro per custodire il profano. Il corpo di Cristo. Il corpo di Claudio. “Bisognava andare a messa, altrimenti non ti facevano giocare”. Ora che il pallone l’ha portato via lui e l’ultima pagina del suo romanzo non somiglia al giornale del quartiere al quale collaborava da adolescente come “barzellettiere”, si fatica a credere che non stia scherzando e pensare al colpo di scena appare sacrilego. Ranieri si ritira. Ranieri lascia il calcio. Il cerchio si è chiuso, Claudio torna a casa. Salvo brevi parentesi, l’aveva lasciata per diventare adulto mezzo secolo fa. Non molto tempo dopo aver usato i tappi delle birre come biglie sulla sabbia nei pomeriggi a Testaccio e quasi in coincidenza con l’esordio in serie A, agli ordini di Manlio Scopigno, uno che sull’isola, proprio come Ranieri, ha lasciato un’impronta che non si cancella. “Non aspiro alla Nazionale, aspiro la Nazionale” diceva Manlio. Lo chiamavano il filosofo. A lui non dispiaceva. Ci marciava: “La cosa più pulita nel calcio è il pallone: quando non piove”. Era spiritoso e malinconico. Arrivò troppo presto al finale di partita, ma sapeva, come Beckett, che non esiste niente di più comico dell’infelicità. Et alors, monsieur Ranieri, ça va mieux? Si piange o si ride all’ora del tramonto? Se Claudio sia triste o sollevato non lo sapremo mai. Sospettiamo che se lo domandi senza avere fretta di trovare la risposta. Tra qualche mese, forse, chissà. Un agguato di nostalgia, la sensazione di trovarsi fuori asse, fuori fuoco, lontano dal suo centro, una telefonata inattesa, una proposta improvvisa. La vertigine. Per imparare il dolore ci vuole pazienza.
Ranieri ha viaggiato per due terzi della sua vita. L’abisso del distacco che da ragazzo, nei primi mesi da esule a Catanzaro, dove rimase a difendere la provincia per quasi un decennio, dove fece il capitano, dove conobbe sua moglie, dove vide per la prima volta che aspetto avesse sua figlia, lo faceva correre a Crotone non appena conclusa la partita per prendere il volo Itavia che lo riportava alle radici, deve somigliare a quello di oggi. All’epoca lo trasformò in consapevolezza. Si era scelto quella vita. E quella vita portava lontano. Non c’era più nido e se c’era, si era svuotato. Ma allora aveva poco più di vent’anni e non è detto che smettere sia più facile che cominciare. Calciatori e allenatori sono apolidi. La loro patria è ovunque e da nessuna parte. I ruoli si confondono. Le priorità annegano. I tuoi figli rischiano di nascere mentre sei in campo, corri in ospedale sudato e in tuta, con il cuore impazzito e tutti i giorni, con un altro ritmo, i gesti lenti, l’olio di canfora e i parastinchi, con gli armadietti e le cene in pizzeria, con le notti estive e le briscole nelle pensioni senza stelle sperdute nelle valli a ripetere ogni giorno un rito che non conosce variazioni, diventi padre, fratello e compagno di altri mille volti, per altre mille volte. Finché le facce cambiano e qualcuno parte. Finché non parti anche tu. Quante partite ha giocato Ranieri? Quante ne ha viste dall’angolo di una panchina, con la giacca e la cravatta? Quante città ha cambiato? Quante lingue ha parlato? Quante volte ha litigato? Quante ha perdonato? Quante, ancora, si è sbagliato? I numeri vanno e vengono. Si vince e si perde. Si parte e si ritorna.
Chissà se domenica scorsa a Reggio Emilia, mentre i suoi lo innaffiavano d’acqua e lui, grato, poteva piangere senza darlo a vedere, ha pensato alle coincidenze. Il 19 maggio del 1974 era sceso in campo per l’ultima volta con la squadra della sua città, la Roma, avversario il Cagliari di Albertosi e Gigi Riva. Il 19 maggio di cinquant’anni dopo si congedava per sempre dal suo mondo salvando il Cagliari dalla retrocessione e mantenendo l’ultima promessa. Colpo di scena. Non lo sapeva nessuno, se lo aspettavano in pochi. Non hanno provato a fargli cambiare idea perché chi lo conosce sa che Ranieri non cambia idea. “Ho un limite che coincide con un’esigenza interiore: se mi guardo allo specchio devo essere sicuro di non sputarmi in faccia”. Era così ieri, è così oggi. Le strade di ieri portano tutte a sud. Le strade di ieri sono piene di terra, polvere e vento. Ci trovi le facce, ci trovi le storie, ci trovi una passione, ci trovi Claudio. Che ha visto imbiancare i capelli e ha fatto in tempo a diventare nonno. Che li ha conosciuti tutti, che se si mettesse a raccontare davvero non basterebbero il confessionale della basilica di San Saba o cinquanta Meridiani. Fare letteratura con la miseria della sua bravura sarebbe semplicissimo. A Ranieri non è mai piaciuto. Non ha mai parlato male di nessuno. Non ha mai parlato troppo bene di sé stesso. Non si è mai preso meriti che non aveva. Se non era d’accordo accostava la porta. Non la sbatteva. E se la sbatteva, come a Lamezia Terme, tra i dilettanti, agli inizi, non ne parlava con nessuno. Si chiama responsabilità. Se l’area di rigore diventava un saloon, ai tempi in cui indossava i pantaloni corti, Ranieri non si nascondeva. Le dava e le prendeva: “Bisognava salvarsi e se c’era da assestare qualche colpo, si assestava. Non mi pento di niente, è andato tutto in prescrizione”.
Dopo il terzo fischio dell’arbitro, però, finiva tutto. Con compagni e tifosi, con avversari e presidenti. A volte domatori del circo, altre padroni del circo stesso. Pittoreschi, eccessivi, meravigliosi, estinti. Ranieri li ha amati quasi tutti. Ernesto Ceravolo: “Con cui una stretta di mano valeva più di mille parole”. Angelo Massimino, a Catania “un uomo buonissimo” che morì, già quasi cieco, andando a cercare soldi per la sua squadra, era fatto a modo suo. Intimava di togliere il salmone dal tavolo: “cameriere, questo prosciutto ha uno strano odore”, si nascondeva dietro le maschere per controllare dalla feritoia dello stadio che tutti pagassero il biglietto: “da quest’anno, lotta totale ai portoghesi!”, e provocava la geografia: “Sto per andare in una nazione che non posso rivelarvi per trattare due campioni brasiliani”. Ranieri lo adorava perché era vero. Lo amava nonostante la squadra lo avesse nominato sindacalista e con il presidente, da scudo umano, dovesse parlare di premi, soldi, trasferte e logistica. Lo stimava anche se la doccia del Tupparello di Acireale, quando i lavori al Cibali furono così clamorosi da costringere la squadra all’esilio, era gelida e sul campo pascolavano le pecore. Lo rispettava perché sapeva riconoscere l’umanità oltre il folklore. Lo sapeva leggere perché le parole gli sono sembrate sempre meno oneste dei gesti. Quando Massimino morì, a Catania, in un marzo più mesto di altri, Ranieri era già a Firenze. Prese un aereo di lunedì, arrivò davanti alla Cattedrale gremita, sollevò il feretro, aveva gli occhi lucidi. A volte i presidenti lo seducevano. “Mario Cecchi Gori era un artista della battuta”. Altre lo abbandonavano. Jesus Gil, ad esempio: il magnate con una fedina penale lunga come la Salerno-Reggio Calabria e la scorrettezza politica come bussola: “Le mie tre figure di riferimento sono Francisco Franco, Gesù e Ernesto Guevara”. L’uomo che lo portò all’Atlético Madrid. “Veniva da me pieno di ottimismo: ‘Compreremo tantissimi campioni, voleremo’. E io ci credevo. Poi arrivarono i poliziotti, le inchieste, gli arresti e l’amministrazione controllata. Gil sparì di scena e di vegliare sul destino dell’Atlético si occupò un giudice: un curatore fallimentare. Una volta mi convocò alla vigilia della gara con l’Oviedo: ‘Se non vince oggi sono costretto ad allontanarla’. Fui più rapido: ‘Non si è mai visto un giudice che esonera un allenatore. La sollevo dal peso, me ne vado io’”. E Gil? Assolto: “Gil era simpatico, Gil aveva fatto la gavetta”. Come Claudio. Che “sui carri e sui carretti” non era mai salito perché c’è stato un tempo in cui a meno di quarant’anni non partivi dalla panchina dell’Inter o del Milan, ma se ti andava bene lottavi a Pozzuoli.
Per i campi in terra con gli appartamenti affacciati sui tubi Innocenti, prima di arrivare a Milano, a Torino o a Londra, Ranieri è transitato. Per le trasferte di Solofra e Battipaglia, Ranieri è passato. Le mani grandi di Tom Rosati che per dirti “ti voglio bene” ti mollava un ceffone, Ranieri le ha sentite. Gli altri, divorati dalla vanità, si mettevano in vetrina. Ranieri si schermiva. Gli altri s’offrivano e lui soffriva alla sola ipotesi. Il suo unico sponsor è stato il suo lavoro. Sua madre gli diceva: “Claudio, si fa con quel che si ha”. Aveva ragione. La storia va guadagnata. Dà più soddisfazione. Andò all’estero quando lasciare “il campionato più bello del mondo” confinava con l’eresia, vinse la Premier League vent’anni dopo con gente che veniva dalla terza serie. E’ stato sempre il più moderno. Come Ancelotti, come Gasperini, come quelli che a dar retta all’anagrafe dovrebbero essere a lucidare le medaglie e invece restano con il fischietto al collo perché si diventa vecchi solo quando si inizia a pensarlo. Era importante la testa: “Senza quella non vai da nessuna parte”. E poi, soltanto dopo, tutto il resto. Ranieri era un ottimo psicologo, ma non era un campione. Metteva tutto quello che aveva da giocatore e lo stesso ha fatto quando, a metamorfosi compiuta, ha indossato altri panni. Ranieri non è mai stato nemico del talento. Ha allenato Batistuta, Careca, Francescoli, Totti, Del Piero, Lampard, Buffon, Zola, Zanetti e altri centomila. Gli piacevano i matti, gli irregolari, i Chinaglia e gli Zigoni. Gli piacevano quelli che non gli somigliavano. Ha sempre saputo come risvegliare l’orgoglio dell’ultimo della fila come del primo, del comandante come del mozzo di bordo. Viene in mente un suo maestro, Carlo Mazzone, che per i gemelli Filippini e per Roberto Baggio aveva la medesima cura. Torna in mente l’ultimo Ranieri. Nessuno voleva in campo Deiola, centrocampista dai mezzi tecnici inversamente proporzionali alla generosità? Deiola, quando abile, in campo è andato sempre e nel giorno dell’ultima fotografia ha persino segnato. Ranieri non ha mai lisciato il pelo alla tifoseria, ma ha saputo farsi amare comunque che è una cosa diversa e molto più preziosa.
Ora, pensare che un signore secondo solo ad Arsene Wenger per presenze a bordo campo, un galantuomo che non ha mai confuso gentilezza e debolezza, carisma e piazzata, egoismo e bene generale, tra qualche mese a bordo campo non sia più, felici non rende. Ranieri iniziò ad allenare quando nei ritiri si faceva la fila davanti al telefono con un sacchetto pieno di gettoni in mano e saluta in un’epoca in cui di artificiale non c’è solo l’intelligenza. Vederlo ancora tra noi consolava. Chiunque arrivi adesso, di certo, non saprà nulla di Tonino Orrù che in un giorno del 1988 lo incontrò a Fiumicino, clandestinamente per offrirgli la prima vera occasione della sua vita. Ranieri aveva 37 anni, veniva da due licenziamenti e pensava a una burla alla Monicelli dei suoi vecchi amici di Catanzaro: “Andai all’aeroporto sicuro della beffa” e si ritrovò a guidare il Cagliari, a conquistare una doppia promozione dalla serie C alla serie A, a iniziare dal Napoli privo di Maradona una serie di imprese dal valore non quantificabile. A Roccaporena, la sede del primo ritiro dei sardi, c’erano una pensione, un santuario e una sveglia che suonava molto presto di mattina. Alle sette e trenta si correva per i boschi. Alcuni giocatori erano stravolti, altri smarriti. Ma comunque, tutti dalla sua parte. Gianluca Festa, centralone di grande acume e lealtà, in quella squadra arrivò giovanissimo: “Il calciatore è un bastardo. Legge tutto in anticipo, ogni minimo particolare. E se nota favoritismi, incongruenze o disparità di trattamento te la fa pagare. Il nostro leader era l’allenatore. Per Claudio ci saremmo gettati nel fuoco, letteralmente. Se Claudio mi avesse detto: ‘Gianluca, buttati dal quarto piano a testa in giù’, lo avrei fatto senza discutere”. Ricordi. Frammenti. Claudio l’educato che un giorno sentì di non potersi trattenere di fronte al reiterato “vaffanculo” di Zibì Boniek: “Questo non te lo permetto, a fare in culo vacci tu”. Claudio che se vede poesia, non ne fa mai una questione di soldi. Claudio che non voleva neanche allenare e invece. Claudio che non c’è curva che non lo omaggi perché i panda vanno preservati. Claudio che sa scherzare, ma se si fa sul serio cambia espressione: “Io amo lo sport e detesto l’avanspettacolo. Se devo ridere vado a teatro”. Claudio, Claudio, Claudio. Adesso a teatro, dopo aver occupato il nostro immaginario e la scena per decenni, andrà con Rosanna, la ragazza figlia di un giornalista incontrata a Catanzaro, la persona che gli sta accanto da mezzo secolo e gli ha visto fare più bagagli che promesse. I patti sono una cosa seria. Non vanno dimenticati. Ranieri ha buona memoria: “Ho sempre guardato avanti stando molto attento a non dimenticare mai niente”. Cercheremo di fare lo stesso: guardare, capire, accettare. Rimpiangere, anche. Certe cose si sanno senza bisogno di studiarle: quelli come Ranieri non esistono più.