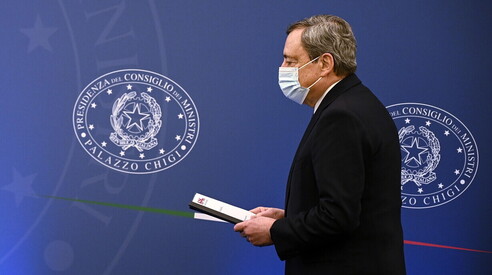
Foto Ansa
Appunti in vista del Colle
Il segreto del metodo Draghi
I leader dei partiti apprezzano, i ministri pure. resta da convincere il Parlamento: sette anni sono meglio di sette mesi
I bilaterali con i leader, le riunioni di quindici minuti, i pre consigli senza odg, le bozze trattenute, i ministri del tu e quelli del lei. Il dietro le quinte di un Cdm raccontato da alcuni ministri, con un modello utile per i prossimi sette anni
Negli ultimi dieci mesi, il profilo di Mario Draghi che è stato spesso raccontato, e che in alcune occasioni è stato anche celebrato, ha coinciso con l’immagine che il presidente del Consiglio ha offerto di se stesso attraverso i risultati ottenuti dall’Italia e attraverso le non frequenti interazioni con l’opinione pubblica avvenute nelle occasioni in cui il capo del governo ha scelto di concedersi alle domande dei giornalisti. A livello pubblico, il cosiddetto metodo Draghi lo si ritrova dunque all’interno di queste due direttrici e se si volesse sintetizzare in modo brusco qual è il modello messo in campo in questi mesi dal presidente del Consiglio si potrebbe dire che il segreto del draghismo è grosso modo questo: depoliticizzare i problemi complessi trasformando ogni soluzione potenzialmente divisiva in una soluzione di buonsenso e facendo della concertazione con tutti i corpi intermedi un’occasione di dialogo finalizzata non alla mediazione tra le parti ma al coinvolgimento di tutti in un processo decisionale all’interno del quale il capo ascolta tutti ma decide da solo.
Del Draghi pubblico si sa ormai quasi ogni cosa, e si conoscono bene anche le sue ambizioni quirinalizie, ma ciò che invece manca nel racconto degli ultimi dieci mesi di vita a Palazzo Chigi è qualcosa che riguarda la dimensione più privata del presidente del Consiglio. Una dimensione che non ha a che fare con la sua vita fuori dal palazzo bensì con la quotidianità di ciò che succede all’interno di Palazzo Chigi.
Abbiamo passato gli ultimi mesi, tra una cosa e l’altra, a raccogliere informazioni per provare a capire qualcosa in più sul metodo Draghi, un metodo che potrebbe tornare utile studiare se davvero sarà questo il metodo che guiderà le danze della repubblica nei prossimi sette anni, e conversando in modo privato con alcuni ministri abbiamo raccolto elementi interessanti per illuminare alcuni tratti del metodo utilizzato dal presidente del Consiglio nei suoi dieci mesi al governo.
Il primo elemento condiviso da diversi esponenti dell’esecutivo, comprese alcune persone molto ascoltate dal premier, riguarda una parola spesso abusata ma che con Draghi è tornata ad avere una sua forza: il potere della delega. In senso largo, si può dire che negli ultimi anni la delega è tornata ad avere una sua centralità nella politica italiana nel momento stesso in cui la stagione dell’uno vale uno è stata archiviata dagli stessi teorici della democrazia diretta (parliamo ovviamente del M5s), che nel corso della legislatura sono passati dal considerare il Parlamento italiano non più un’istituzione da asfaltare ma un’istituzione da proteggere con i denti anche per respingere, con la forza del compromesso, i deliri populisti di alcuni capi di partito desiderosi di guidare il paese imponendo il modello dei pieni poteri. La delega a cui facciamo riferimento quando parliamo di Draghi non è però quella parlamentare, ma è quella che riguarda un’attitudine del presidente del Consiglio che ha archiviato la stagione del “divide et impera” per passare alla stagione del “delega et impera”. Da quando è arrivato a Palazzo Chigi, Draghi (che, piccolo dettaglio di colore, a Palazzo Chigi è chiamato dalle persone più vicine a lui non “il premier” ma “il capo ufficio”) ha sempre scelto di seguire in prima persona pochi dossier, prima erano le vaccinazioni, poi il Pnrr, ora è l’attuazione del Recovery, e ha sempre delegato ad alcuni ministri (due in particolare: Daniele Franco e Vittorio Colao), ad alcuni sottosegretari (uno in particolare: Roberto Garofoli) e ad alcuni consiglieri (due in particolare: Francesco Giavazzi e Marco Leonardi, non Marco D’Alberti, non particolarmente centrale nelle dinamiche di Palazzo Chigi e non molto amato dalle truppe che si trovano a Chigi) il compito di monitorare il resto delle pratiche, dando ai delegati piena autonomia per portare avanti anche le trattative più importanti. Lo schema è sempre lo stesso: partire dall’idea non di dover mettere tutti d’accordo ma di chiedere a tutte le forze politiche un contributo per portare avanti una propria visione (sulle partite di carattere economico il mandato finora è stato questo: stato dove si deve, mercato quando si può).
E tra le modalità con cui il presidente del Consiglio ha provato in questi dieci mesi a guidare alcuni propri processi decisionali se ne possono isolare due.
La prima riguarda tutto ciò che succede prima del Consiglio dei ministri, fase dominata da Roberto Garofoli, e la seconda parte riguarda tutto ciò che succede in Consiglio dei ministri, dove alcune meccaniche di potere spiegano meglio di ogni retroscena come funziona quel particolare mix di tecnica e politica incarnato dalla figura del premier. La prima fase avviene qualche giorno prima della convocazione di un Consiglio dei ministri importante, quando Roberto Garofoli convoca tutti i capi di gabinetto dei ministeri, che vengono chiamati a raccolta a Palazzo Chigi in modo periodico senza essere messi al corrente dell’oggetto della discussione per cui sono stati invitati. Si tratta di un metodo rodato che in una prima fase aveva fatto indispettire diverse strutture ministeriali ma che nel corso del tempo è stato via via accettato e riconosciuto come un processo efficiente di risoluzione dei problemi. Funziona così. Garofoli convoca tramite sms tutti i capi di gabinetto, li riunisce in una stanza, spiega al momento del loro arrivo a Palazzo Chigi l’oggetto della riunione, offre loro uno o più provvedimenti che dovranno essere portati in Consiglio dei ministri, i capi di gabinetto discutono a volte in modo anche molto animato dei provvedimenti e alla fine della discussione si fissano dei paletti condivisi che vengono trasferiti alle strutture dei ministeri. E’ una fase preliminare, naturalmente, quasi una camera di compensazione delle problematiche, che sfrutta l’estemporaneità delle riunioni per andare al sodo dei problemi, “per creare un habitat”, ci dice un ministro, e che offre successivamente a tutti i ministri uno spazio politico entro il quale muoversi per arrivare al Consiglio dei ministri, con la consapevolezza precisa di quale sia lo spettro politico entro il quale è possibile avere un margine di discussione con il premier.
E qui arriviamo al secondo punto. Ma come funzionano, esattamente, i Consigli dei ministri, con Draghi? Quali sono le dinamiche che governano tali riunioni? In che modo il capo ufficio ha provato a trasferire il suo metodo nei rapporti con i partiti? Un primo elemento riguarda le cosiddette bozze dei provvedimenti, che spesso sono gli stessi ministri a leggere per intero solo quando si trovano in Cdm, e un tecnico di lungo corso che lavora al Mef, e che ha visto in prima persona il modo in cui hanno lavorato diversi primi ministri, ci spiega qual è l’approccio che ha su questo tema il premier attuale: “Draghi, in modo a volte anche un po’ forzoso, ha scelto di non far girare le bozze dei provvedimenti prima dei Cdm, e ogni ministero ha solo un pezzo del pacchetto generale. Nessuno, tranne Colao e Franco, e naturalmente Garofoli, ha una visione generale di quel che finirà in Cdm, e la scelta è esplicita non solo per accentrare tutto a Palazzo Chigi ma anche per evitare che le scelte del premier possano essere influenzate dal dibattito generato dalla pubblicazione delle bozze sui giornali. In alcuni governi del passato, invece, penso alla stagione di Conte, far filtrare le bozze era quasi un metodo di lavoro: si diffondeva quanto più possibile qualche velina prima di un Cdm, si registrava l’umore dei giornali e poi si correggevano eventuali scelte impopolari”.

Per provare a capire qualcosa di più sul funzionamento del Cdm ci affidiamo al racconto, off the record, di alcuni ministri esperti, che ne hanno viste tante negli ultimi anni e che conoscono bene le differenze tra uno stile e un altro di gestione dei processi decisionali. Generalmente, dice uno dei ministri con cui abbiamo parlato, con Draghi “i Cdm tendono a durare poco e tendono a essere dominati dalle parole del presidente del Consiglio. Poche interruzioni, poche discussioni. Durante le riunioni, i ministri che vogliono intervenire lo fanno alzando la mano e se ci sono delle occasioni in cui qualcuno vuole manifestare una qualche forma di dissenso nei confronti di ciò che ha detto il capo del governo la formula difficilmente è ‘non sono d’accordo’ ma è ‘presidente, se si può considerare anche questo elemento’”. In alcune occasioni, racconta un altro ministro, anch’egli esperto, può capitare che Draghi, come è stato quando si è discusso in modo animato in Cdm del prelievo di solidarietà, sospenda la seduta, dicendo: “mi ritiro per deliberare”. Quando questo succede, capita che il premier si ritiri con Roberto Garofoli, Daniele Franco e Antonio Funiciello, che è il capo di gabinetto di Draghi, sì, ma è anche la cinghia di trasmissione del presidente del Consiglio con tutti i leader di partito. Poi Draghi rientra con una soluzione. “Una caratteristica interessante del metodo Draghi – dice un altro ministro – è che il premier, quando c’è un problema da risolvere con una qualche parte politica, sceglie sempre, come capita spesso nel mondo della finanza, di audire qualcuno a livello bilaterale. Draghi lo fa spesso prima dei consigli dei ministri, in preparazione dei quali passa molto tempo al telefono con i leader e con i capi delegazione, e ciò che tutti noi ministri abbiamo notato è che se il presidente deve risolvere un problema non lo fa mai in gruppo. Questo è un approccio diverso, direi opposto, rispetto a quello che aveva il suo predecessore, che purtroppo scaricava gran parte dei problemi politici all’interno del Consiglio dei ministri e che purtroppo sceglieva spesso di aprire al buio i Cdm chiudendo solo a tarda notte quando si trovava un’intesa. Un approccio che può essere anche comprensibile ma che nel passato ha contribuito a creare un logoramento dei rapporti tra i leader e le forze politiche e ha scalfito anche l’autorevolezza dell’ex premier. Perché se tu devi discutere in un dibattito di fronte a tutti, il dibattito presenta anche alcune incertezze e di fronte alle incertezze è naturale mostrare delle debolezze. I dibattiti ci sono anche oggi in Consiglio dei ministri, ma le mine sono state tolte dal terreno prima, in Cdm si arriva per decidere, non per discutere, e anche il ruolo del Mef, rispetto al passato, appare essere molto diverso: il Mef non è una camera di compensazione di Palazzo Chigi, è il braccio operativo del governo, e non avere una tensione continua tra Chigi e Mef aiuta il governo a prendere decisioni più rapidamente”.
Un terzo ministro ci racconta un altro dettaglio del metodo Draghi che riguarda sempre i bilaterali (quelli non telefonici, di persona, durano di solito non più di quindici minuti): “Quando lo chiami al telefono, è difficile che Draghi non risponda, se non lo fa richiama al massimo dopo mezz’ora, se non risponde subito a un messaggio lo fa dopo un’ora al massimo, non so se fa così con tutti, ma certamente con i ministri che contano e che pesano nei partiti Draghi lo fa con costante precisione certosina”. Il ministro in questione racconta anche un altro dettaglio: “Esiste una sorta di manuale Cencelli di Draghi nella gestione del potere in Consiglio dei ministri e quel manuale lo si può ricavare facilmente da un dettaglio che ogni ministro nota ogni volta che si convoca un Cdm: a chi Draghi da del tu e a chi da del lei. Non è solo una questione di formalità, è una questione di gestione del potere, oltre che dei rapporti personali, e dieci mesi dopo la nascita del governo attraverso i ‘tu’ in Consiglio dei ministri si capisce con chi Draghi ha scelto di costruire un rapporto più confidenziale. E se il tu e il lei non sono sufficienti per capire quali sono i ministri con cui Draghi va più d’accordo, si potrebbe fare uno sforzo in più e vedere quali sono i ministeri più premiati economicamente in questi mesi e quelli più penalizzati”. Su chi sono i ministri ai quali Draghi dà del tu ci sono diverse ricostruzioni, non tutte coincidenti, ma c’è qualche punto fermo: Draghi dà del tu a Giancarlo Giorgetti, a Luigi Di Maio, a Dario Franceschini, a Renato Brunetta, a Daniele Franco, a Vittorio Colao, e dà del lei a quasi tutti gli altri. Nel rapporto tra Draghi e la politica però l’elemento di fragilità più importante che notano diversi ministri è quello che si registra nei rapporti non tra Draghi e i partiti ma tra Draghi e i gruppi parlamentari e l’elemento vero che è mancato in questi mesi al presidente del Consiglio è stato proprio questo: non riuscire a trasformare la complicità costruita con i ministri (scelti da Draghi a Mattarella, non dai leader di partito) in una complicità di fondo costruita con il Parlamento. Draghi questo lo sa, sa che il suo principale ostacolo sulla strada del Quirinale non sono i leader dei partiti (quando Draghi non ha rapporti eccellenti con i leader di partito, come succede con Conte, prova a ovviare parlando con chi ha il vero potere nei partiti: per il M5s è il caso di Grillo e di Di Maio), molti dei quali non vedrebbero in modo drammatico neppure un’elezione anticipata, ma sono i gruppi parlamentari, che per quanto possano essere convinti dall’idea che l’Italia con Draghi al Quirinale per sette anni potrebbe essere più stabile faticano a convincersi dell’idea che la legislatura senza Draghi a Palazzo Chigi possa essere più stabile. E’ per questo che Draghi, qualche giorno prima della conferenza di fine anno, ha convocato per la prima volta a Palazzo Chigi tutti i gruppi parlamentari (compreso Coraggio Italia), ed è per questo che Draghi nella conferenza stampa di fine anno (o di fine mandato) ha inviato diversi messaggi rassicuranti al Parlamento: “Il lavoro può continuare indipendentemente da chi sarà premier”; “Gli italiani tengono alla stabilità politica e i partiti lo hanno capito”.
Deideologizzare le questioni complesse trasformando le soluzioni divisive in soluzioni di buon senso e creando con i leader che contano nei partiti rapporti bilaterali per dribblare i conflitti e creare un consenso trasversale. Negli ultimi dieci mesi, il metodo Draghi, dentro il Palazzo, ha funzionato così. I leader dei partiti apprezzano, i ministri pure, resta solo da convincere il Parlamento, che dieci mesi fa osservava l’arrivo di Draghi con gli occhi a cuoricino e che dieci mesi dopo osserva i movimenti di Draghi pensando più ai prossimi sette mesi che ai prossimi sette anni.






