
foto LaPresse
Perché l'Italia del rugby non vince
Cambiano gli uomini, restano le sconfitte. Le ragioni di un declino e quelle per sperare in una rinascita
Ora non li vuole più nessuno, non se li piglia più nessuno. Prima le birre, il Terzo Tempo, l’etica, i valori, i bambini buoni contro quelli cattivi e cafoni del calcio, il manicheismo ovale come unica regola e ora lo scherno quando non proprio l’indifferenza. Gli Azzurri del rugby sono passati all’incasso della ventitreesima sconfitta di fila nel Sei Nazioni, il torneo tanto sognato che ora è diventato un incubo. Cambiano gli allenatori, cambiano gli uomini e non cambiano i risultati, come fosse il Lustro della Marmotta, partite tutte uguali o poco diverse, la retorica della testa alta che non tiene più, che non consola più nessuno. Con la Nazionale perde il Movimento, dicono tutti così e a forza di ripeterlo è diventato vero. Ma andreste mai a scassare l’anima a un generico tifoso calcistico per le sconfitte della Nazionale? Gli rinfaccereste la responsabilità di Italia-Svezia per il solo fatto di amare il calcio? A un ferrarista appassionato rinfaccereste le eleganti carriole degli ultimi anni? No, ma al rugby sta succedendo. Spariti i tifosi occasionali, i bandwagon in fuga verso altri sport più fortunati e spendibili al bar, i rugbisti per vocazione (il Movimento), sono rimasti soli, scossi e attoniti. Il fatto è che non l’avevano chiesta tutta quella attenzione, ci si sono ritrovati e hanno cavalcato quell’onda maestosa di opportunismo emotivo. L’Italia del rugby che prima serviva a educare i popoli all’amore universale alla lunga non s’è desta, lentamente e inesorabilmente s’è ammosciata, depressa, sfibrata fino a ritrovarsi al punto di partenza. Anzi prima, più in basso, all’inferno delle verità e senza nemmeno un sorriso con cui mentire. Nuda alla meta. Senza meta, per la verità. Nel Movimento c’è chi rifiuta sdegnato il confronto, chi si affligge in silenzio e chi si interroga sui perché di un disastro.
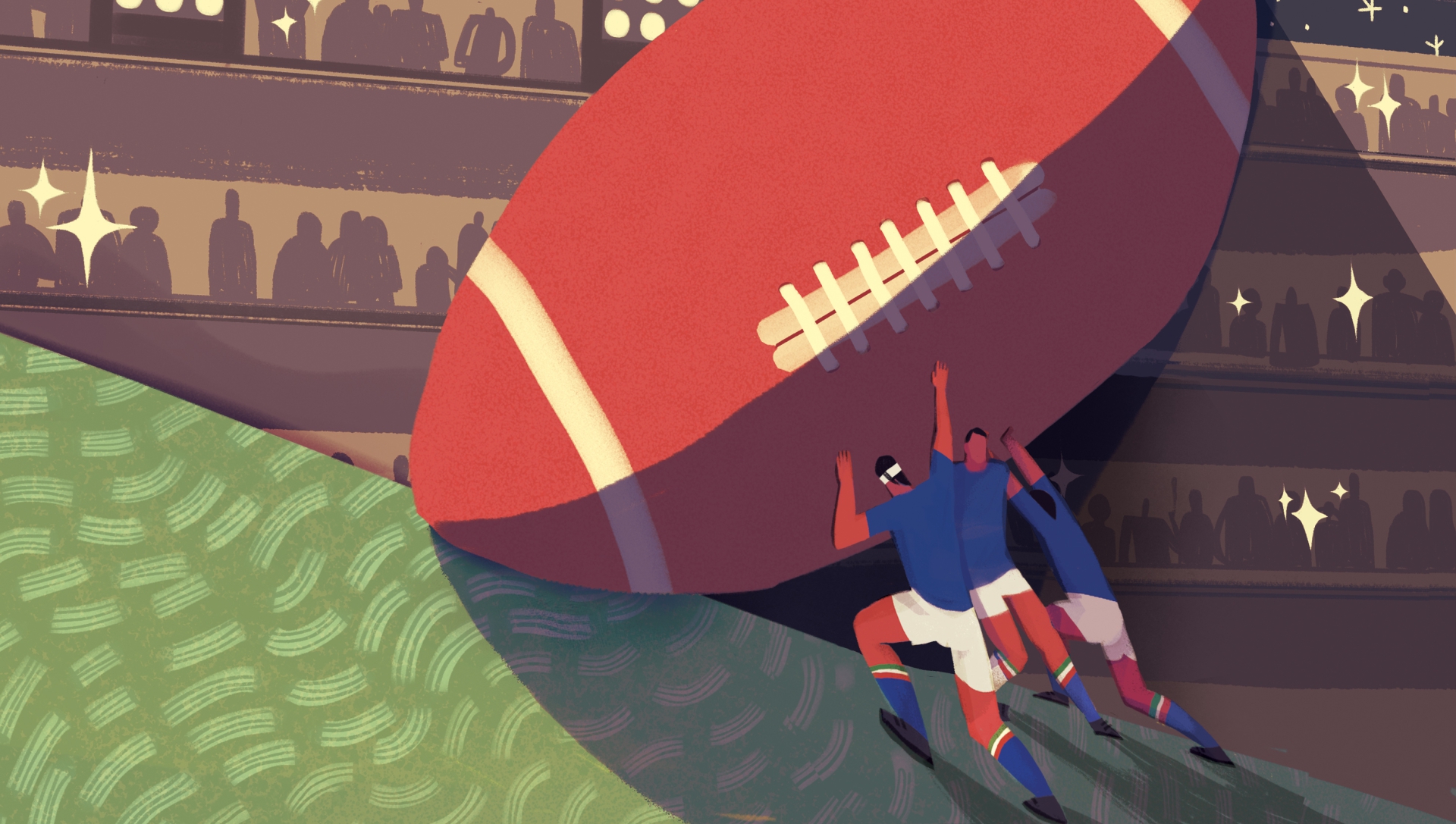
Illustrazione di Margherita Barrera
A dire il vero i perché sono chiari, una parabola lineare e molto umana. Perché di uomini si tratta, della somma di competenze e incompetenze, del risultato di un lungo cammino all’indietro. Il rugby italiano deve il suo periodo d’oro a una splendida generazione di atleti e all’intuizione di un uomo intelligente e scaltro. In campo scendevano prima Giovannelli, Dominguez, Cutitta, De Carli e poi Troncon e tanti altri ancora che hanno trascinato l’Italia nel club esclusivo delle migliori squadre del mondo. Dietro alla scrivania e in ogni punto d’incontro del vero potere c’era Giancarlo Dondi da Parma, ex seconda linea e dirigente d’azienda con una forte capacità di visione, uno che dice spesso che se il tuo sogno non fa ridere nessuno, non è un buon sogno. Uno che aveva sognato di portare l’Italia nel salotto buono e per farlo ha usato l’intuizione più pura, s’è giocato tutte le carte sulla Sindrome di Stendhal di inglesi, gallesi, irlandesi e scozzesi in giro per Roma con fiumi di denaro da trasformare in birra e presenze in albergo, il miracolo della conversione della bellezza in oro. Certo ci voleva una grande squadra per reggere l’urto dei maestri e in quegli anni gli astri si allinearono a modino. Esordio con la Scozia, vittoria. Quello era un gruppo competitivo e talentuoso con alcuni atleti di una categoria superiore, Diego Dominguez su tutti. Ma non dura mai in eterno. I giapponesi dicono kaizen, cambiare quando le cose vanno bene. I giapponesi sono quelli che hanno imparato a giocare a rugby in 15 anni e ora girano per tornei a fare il mazzo a squadre di grande blasone e tradizione.
Il rugby italiano non ha cambiato formula, è rimasto identico a sé stesso, sono invecchiati i giocatori, sostituiti da altri giocatori, rimpiazzati da talenti diversi, più piccoli, meno imprevedibili. La decrescita infelice. Poi è arrivata una generazione molto salottiera di atleti che hanno scelto di monetizzare la popolarità del rugby e celebrarsi nonostante i risultati non arrivassero, la squadra scricchiolasse e fosse sempre più abituata a perdere. Quando diventi la sesta squadra del Sei Nazioni i casi sono due: puoi passare la vita a ricordare a tutti che comunque sei più forte delle Nazionali escluse o cominciare a interrogarti sul perché le cose non cambino e non ci siano buone nuove all’orizzonte. La verità è che sbaglia chi sostiene che dovremmo uscire dal Torneo. Bisogna restare e piuttosto cercare di capire chi dovrebbe uscire dal rugby italiano.
Dirigenti che hanno studiato alla scuola di Erode e massacrato intere leve di ottimi giocatori ancora in culla. Dirigenti che hanno fatto fallire e poi di nuovo fallire ricche franchigie federali, trascinando alcune colonne del rugby italiano nel fango e nel grottesco. Dirigenti inossidabili, incapaci di capire che il loro tempo è passato, legati a carriere eterne, emolumenti pesantissimi, competenze misteriose. Il rugby italiano si è avvitato su sé stesso, dopo Dondi il diluvio e troppo semplice sarebbe accollare tutte le colpe a chi lo ha sostituito alla guida della Federazione. Non esistono uomini soli al comando, esistono strutture capillari di governo, persone responsabili.
La Nazionale è la punta di una gigantesca montagna sommersa, un massiccio di errori e pasticciacci brutti che alla lunga si è mangiato tutto il lato luminoso della forza. Burocrati della sopravvivenza, incuranti del costo emotivo della loro mediocrità. Così il cerino di un momento disgraziato è rimasto in mano ai due protagonisti meno colpevoli, agli innocenti. Giocatori e tifosi rimasti senza ombrello, stretti in un abbraccio dignitoso e triste.
La Nazionale che arranca e i fedelissimi che salutano sconfitta dopo sconfitta senza mai lagnarsi.
Mi spiace per i ragazzi in campo, dicono, ed è bellissimo e struggente. Intanto però le ragazze vincono, le giovanili se la cavano bene, la notte non è infinita.
Arriveranno le vittorie, tornerà qualcuno capace di sognare, arriverà un carro nuovo su cui saltare passate le elezioni. Resterà tutto questo amore puro e pudico, la complicità tra compagni di sconfitte, arriverà la Scozia.
Quella torna sempre.
Michele Dalai è nato a Milano nel 1973, editore, scrive e lavora per radio e televisione. È è il fondatore di Medical Facts





