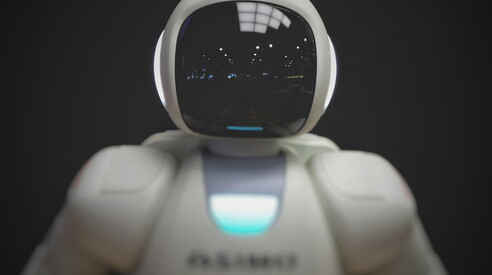IL FOGLIO DEL WEEKEND
Facebook sotto assedio, i tormenti del non più giovane Zuckerberg
Anatomia del quinto potere: il social network più famoso del mondo, nato per connettere le persone, è davvero diventato uno strumento spietato e crudele? Indagine su una piattaforma e sul suo fondatore, caduto dall’Olimpo
La storia s’è fatta teatro. C’è la Erinni vendicatrice, Frances Haugen, la dirigente pentita che rivela recondite disarmonie; c’è la Circe incantatrice, Sheryl Sanders, brillante economista, la capo azienda che instilla il veleno del profitto e trasforma in porci gli ignari naviganti del web; c’è il malefico consigliere interpretato dal conservatore britannico sir Nick Clegg, ex vice primo ministro di David Cameron passato dalla politica agli affari, e il Signore delle tenebre, Joel Kaplan, lobbista capo che tratta con i politici e distilla il siero dell’onnipotenza; e c’è la foresta dei giustizieri in marcia contro il castello dei soprusi, anche se manca ancora un Fortebraccio. La saga di Facebook e del suo fondatore ha raggiunto il climax drammatico.
Mark Zuckerberg aveva cominciato tra amici e studenti dell’università di Harvard che si scambiavano notizie sulle ragazze più carine, poi si è fatto trascinare da quella catena di sant’Antonio informatica ed era diventato ricco (a 23 anni già miliardario, oggi ha un patrimonio di 130 miliardi di dollari numero cinque al mondo) entrando in una terra incognita della quale non conosceva le tortuose strade. Nemmeno lui del resto poteva mai immaginare che i giochi della prima giovinezza lo avrebbero portato in un gioco ben più grande, quello tra libertà e responsabilità, nel quale si consuma la democrazia. Ha scritto lo psicologo canadese Laurence Peter che ha svelato i meccanismi interni alle grandi organizzazioni economiche e burocratiche: “Ogni cosa che funziona per un particolare compito verrà utilizzata per compiti sempre più difficili, fino a che si romperà”. Zuck è giunto in cima alla “piramide di Peter”?
“Il tempo è scaduto”. L’onorevole Ed Markey senatore democratico del Massachusetts suona la campana: “Ecco il messaggio per Zuckerberg: il tempo che ti consentiva di invadere la nostra privacy, di promuovere materiale tossico per i nostri figli e di lasciare che predatori minacciassero i minorenni, è scaduto”. E il tempo di trasformare i dati, le informazioni degli utenti in capitale, senza che ai legittimi possessori venga dato nessun ritorno? Il nocciolo duro del modello di business in tutti i social media comincia a essere messo in discussione alla radice. “Facebook è una scatola nera”, incalza Richard Blumenthal anche lui senatore democratico della costa dell’est (eletto nel Connecticut), già procuratore generale del suo stato, un vero crociato nella lotta contro gli abusi sull’infanzia via internet. Ma dentro quella scatola nera cominciano a entrare in molti: i giornalisti d’inchiesta, come quelli del Wall Street Journal (che non è esattamente l’organo della sinistra radicale) in gara per il premio Pulitzer, o il Time, che mette in copertina “cancella Facebook”, i rappresentanti del popolo sovrano, i magistrati, i cani da guardia del mercato e dell’informazione, gli ex manager che spifferano i segreti (confermando in realtà quelli che erano segreti di Pulcinella) e soprattutto gli stessi utenti. In più ci si mettono anche i black out tecnologici, quasi a dimostrare che tutto rischia di finire fuori controllo.
Zuck non era nato per fare l’editore e aveva resistito anche agli inviti di Donald Graham, l’ex padrone del Washington Post consigliere indipendente di Facebook fino al 2015. Siamo “il quinto potere”, così disse, in grado di dare voce non filtrata né modificata a tre miliardi di utenti a differenza dal “quarto potere”, quello dei media, che chiamavano re e presidenti a render conto del loro operato. Ha sempre dichiarato di non voler essere coinvolto in politica, poi ha bilanciato i vertici della sua impresa tra democratici come Sanders e repubblicani come Kaplan. Lo stesso ha fatto nel consiglio di amministrazione anche se non conta nulla, perché Facebook ha un solo uomo al comando. Zuckerberg ha seguito quella equidistanza di facciata anche dopo che i suoi uomini avevano scoperto le intromissioni degli hacker russi nelle elezioni americane per favorire la vittoria di Trump nel 2016, e che si preparavano nel 2017 a replicare in Francia contro Macron a favore di Marine Le Pen. Informazioni riservate che non possedevano nemmeno i servizi segreti, informazioni da tenere nel cassetto perché non avrebbero fatto piacere a Trump pronto a rivalersi contro Facebook, ma soprattutto perché voleva tenersi fuori dalla mischia che aveva provocato. E’ stato così con i massacri in Myanmar o con le violenze razziali, con The Donald che comprava spazi a suon di milioni e diffondeva veleno senza limiti. E così via.
Zuckerberg non sentiva nessun dovere civico di informare il pubblico perché lui non pubblicava un giornale né possedeva una tv. La sua doveva restare la tribuna aperta dove ciascuno poteva dire quello che voleva. Mettere in contatto più persone possibili, senza chiedersi chi e per che cosa. Tutti, anche ai razzisti, anche a chi non crede all’Olocausto. “Io sono ebreo”, spiegò in un’intervista, “e chi nega la Shoah mi fa orrore, ma sono fermamente convinto che Facebook non debba essere l’arbitro della verità”.
Poi è arrivata la pandemia con Trump che pubblicizzava la candeggina e i raggi ultravioletti. E’ arrivato l’assalto al Campidoglio. Ed è arrivata Fances Haugen, 37 anni, ingegnere informatico, ex project manager, la gola profonda, la whistleblower. Uscita da Facebook nel 2019, ha impiegato due anni per elaborare quella che ha definito “una verità spaventosa”, ha portato con sé oltre diecimila documenti perché “nessuno conosce quello che accade dentro l’azienda”, ha detto nell’audizione al Senato americano, li ha mandati al Wall Street Journal, al Congresso e alla Sec, la commissione che vigila sulle società quotate in Borsa. Durante la sua testimonianza ha rivelato che secondo una indagine interna, almeno il 6 per cento dei bambini ha ammesso di essere dipendente da Instagram. E questo, ha aggiunto Haugen, è “materialmente nocivo alla salute, al lavoro scolastico, alla salute fisica”. Non solo, Facebook ha mentito anche al mercato sul numero degli utenti giovani, i più preziosi per la pubblicità, da offrire a caro prezzo: sono ormai in calo anche durante la pandemia quando tutti erano attaccati ai computer.
L’attacco ancor più corrosivo riguarda il funzionamento stesso della macchina del fango: è stato introdotto un algoritmo per aumentare le “interazioni socialmente significative” incentivando i post più divisivi e la disinformazione. In realtà come funziona lo spray dell’odio era stato rivelato già dal New York Times. Ora arrivano le conferme. A settembre il Wall Street Journal ha pubblicato sei lunghi articoli nei quali c’è di tutto e di più, compresa l’esistenza di un programma chiamato XCheck che scherma e protegge milioni di Vip che possono collegarsi al riparo da click indiscreti. Allora, com’è la leggenda che uno non vale uno? Che fine fa il mantra degli smanettoni recitato in continuazione da Zuckerberg: io consento a tre miliardi di utenti possano comunicare alla pari con l’élite? Frances Haugen non è la prima. Da anni emergono con sempre maggiore frequenza le proteste dei dipendenti e degli stessi dirigenti. Ma finora i manager in aperto contrasto con la politica aziendale se ne erano andati. Nessuno aveva scagliato l’anatema sulla pubblica piazza. Adesso invece è arrivata l’ora delle talpe, l’ultima è Sophie Zhang licenziata nel 2020 per scarso rendimento. Ed è solo l’inizio.
“Le accuse non hanno alcun senso”, ha replicato con il suo accento oxoniense Clegg che interpreta al meglio il ruolo del cattivo. “L’argomentazione che deliberatamente spingiamo contenuti che rendono le persone arrabbiate solo per fare profitto è profondamente illogica”, ha aggiunto, “ Facciamo soldi con le inserzioni e gli inserzionisti continuamente ci dicono che non vogliono che i loro annunci siano vicino a contenuti dannosi”. Negare, negare tutto, così comunica Facebook? Più volte Zuckerberg si è piegato a scusarsi per gli effetti collaterali della sua piattaforma, senza per questo cambiare rotta. Ha introdotto sistemi di controllo interni, si è affidato all’intelligenza artificiale in grado di intercettare, a suo avviso, il 90 per cento dei messaggi nocivi, solo che anche quel 10 per cento che sfugge provoca un effetto valanga, è il venticello della calunnia che si trasforma nel temporale della menzogna. Dopo quattro anni di continui sussulti, Zuckerberg affronta l’ultima tempesta con un approccio aggressivo. “Sono stato un manager in tempo di pace, adesso sono un manager in tempo di guerra”, ha detto al suo staff invitando tutti a serrare i ranghi e contrattaccare.
Sembrava che lo scandalo di Cambridge Analytica scoppiato nel 2018 avesse segnato una svolta, ma non è stato così. Le prime rivelazioni che hacker russi si erano erano intromessi massicciamente nelle elezioni presidenziali americane per favorire Donald Trump erano emerse nel 2017, poi è spuntata la società che dalla Gran Bretagna aveva risucchiato da Facebook le informazioni su 87 milioni di ignari utenti, utilizzando i dati per screditare politici, lanciare accuse infondate, diffondere notizie tanto eclatanti quanto inverosimili. Zuckerberg era caduto dal pero e aveva scaricato in parte le responsabilità sulla sua vice. Secondo il Wall Street Journal durante un incontro il gran capo ha accusato Sheryl Sandberg personalmente per l’esito dello scandalo di Cambridge Analytica, lei “ha confidato agli amici di essere rimasta sconvolta e si è chiesta se dovesse preoccuparsi per il suo lavoro”.
La Sandberg ha avuto un ruolo chiave nel trasformare la piattaforma in un Behemoth digitale e lo ha ancora. Nata a Washington nel 1969 da una famiglia ebraica della classe media, si laurea a Harvard dove entra nelle grazie di Larry Summers, che seguirà al Tesoro durante il secondo mandato di Bill Clinton. Quando arriva George W. Bush alla Casa Bianca, la rampante economista va a lavorare da Google, e nel 2007 accetta il posto che gli offre Zuckerberg incontrato durante una festa di Natale. Prima del suo ingresso, non s’era visto un profitto, lei introduce la mucca da mungere e convince Zuckerberg ad accettare la pubblicità “in modo discreto”, così si disse. Oggi Facebook si spartisce con Google il mercato delle inserzioni. I primi utili arrivano nel 2010 e da allora s’impennano, sfiorano i 30 miliardi di dollari l’anno scorso su 86 miliardi di fatturato con 58 mila dipendenti. Ma a Wall Street capitalizza ben 912 miliardi. Ha in cassa talmente tanta liquidità da poter pagare qualsiasi multa le autorità di Borsa o quelle giudiziarie possono comminare. Se, come molti chiedono, verrà smembrata scorporando Whatsapp e Instagram, potrà andare avanti lo stesso e si rifarà in uno dei tanti rami della pianta digitale, per esempio le conferenze in streaming, è da tempo che Zuck mira a Zoom. Nessuno al Congresso, né i repubblicani né i democratici, può mai osare di cancellare Facebook. Lo faranno gli utenti?
Cambridge Analytica è stata bandita, molto più difficile si è rivelato bandire Trump. Pressato dai fatti, ma anche dal crescente turbamento nello staff di Facebook per l’uso trumpiano della piattaforma, Zuckerberg decide di presentare le sue rimostranze direttamente al presidente. Viene ricevuto nell’ufficio ovale da Trump insieme al genero Jared Kushner e a Dan Scavino, l’uomo addetto ai social media. Dopo i primi convenevoli The Donald passa all’attacco, aveva già detto che Facebook gli era sempre stata contraria, adesso proclama di non credere ai social. Zuck pensa che sia meglio blandirlo: con 28 milioni di follower l’account presidenziale è un grande successo, lui e i suoi uomini sono bravissimi nell’uso del mezzo. Certo, non può non aggiungere che certi toni e certi contenuti gli creano imbarazzo, ma subito si passa alla Cina, a Huawei, alla concorrenza di TikTok e WeChat, vere spine nel fianco. In men che non si dica il giovane smanettone e il vecchio volpone si trovano d’amore e d’accordo. L’incontro dura due ore, dovrebbe restare riservato, ma Trump posta su Twitter e Facebook la foto di una cordiale stretta di mano tra sorrisi a tutta dentiera. Didascalia: “Piacevole incontro con Mark Zuckerberg oggi nello studio ovale”. Un successo per Clegg e Kaplan, altri mal di pancia nella Silicon Valley.
In vista delle elezioni del 2020 Clegg è molto chiaro: “Non sottoponiamo i fatti esposti nei discorsi dei politici ad alcun controllo, anche quando contravvengono alle norme sui contenuti”. La regola vale anche per gli annunci pagati. Poi succede il patatrac. Nessuno, nemmeno l’ala destra di Facebook avrebbe mai potuto immaginare uno sciamano cornuto a Capitol Hill e gli sfascisti incitati da un presidente che rifiuta il risultato elettorale. Il 7 gennaio, il giorno dopo quello che è sembrato un tentato golpe, l’account di Trump viene sospeso, prima a tempo indeterminato poi a giugno si decide fino al 7 gennaio 2023, dopo di che un comitato di esperti indipendenti valuterà. Facebook perde un bel po’ di dollaroni (solo nel 2017 il team presidenziale aveva investito 100 milioni), ma cerca di salvare la faccia.
Un diluvio di dati, per usare la felice immagine dell’Economist, ha trasformato il mondo. E’ nato e a poco a poco è diventato dominante “il capitalismo della sorveglianza”, come lo chiama Shoshana Zuboff, la Cassandra del web, che si lancia in una profezia apocalittica: “Se la civiltà industriale ha prosperato a spese della natura e ora minaccia di distruggere la terra, una civiltà dell’informazione dettata dal capitalismo della sorveglianza potrà prosperare solo a spese della natura umana, minacciando di distruggere la nostra stessa umanità”.
E se invece fossimo alla vigilia di una nuova svolta? Se, come sostiene la Harvard Business Review, stesse nascendo una “èra degli antisocial media”? Forse esagera, ma certo tutti ormai abbiamo capito che siamo stati presi per i fondelli: abbiamo ceduto le nostre identità e abbiamo ricevuto indietro il caos. I dati personali possono essere gestiti privatamente, ma restano pur sempre di ciascuno di noi. Si dice che di per sé non hanno valore di scambio, debbono essere estratti e processati e questo è il compito esattamente di compagnie come Google o Facebook che poi li offrono sul mercato. Nemmeno il petrolio valeva niente prima dell’èra dell’automobile, anche il greggio viene estratto, lavorato, processato, ma gli sceicchi che lo posseggono e non per loro virtù, ma per fortuna, accampano un diritto di proprietà; per questo, solo per questo, vengono pagati. La vita, i pensieri, i desideri delle persone non possono essere paragonati a nessun elemento della natura, hanno un valore intrinseco, morale se vogliamo prima ancora che mercantile. E questo riguarda anche l’informazione, perché quella via web dovrebbe fare eccezione?
Il quinto potere contro il quarto potere, i nuovi media contro i vecchi che si stanno ribellando come dimostra l’assedio dei grandi giornali a Facebook. C’è un nucleo di verità sotto tanta fuffa, ma, scrive Maria Savona, docente all’Università del Sussex, la questione è un’altra: “Le nostre identità digitali possono essere considerate come creazioni intellettuali uniche e ognuno di noi è autore delle proprie storie personali. L’utilizzo e la riproduzione delle nostre storie personali per fini di lucro dovrebbe dare diritto alla protezione e al riconoscimento di un diritto d’autore. Non si tratta dunque di definire e regolare la proprietà dei dati personali. Si tratta di riconoscere un diritto individuale di natura fondamentale”. Ci sono alternative? L’idea di “piattaforme cooperative”, spiega Nick Snricek autore del “Capitalismo digitale” non sembra realizzabile. C’è lo stato, evocato non in chiave repressiva, ma operativa da Snricek che parla di “creare piattaforme pubbliche di proprietà e controllate dalla popolazione (e cosa importante autonome dal sistema di sorveglianza dello stato)”, tre condizioni in sé davvero difficili da realizzare. La proprietà statale non supera certo il dilemma dell’identità e della proprietà intellettuale. Per la verità, nemmeno far pagare i dati risolve il conflitto essenziale tra libertà di parola e diritto alla privacy.
L’appropriazione dei dati diventa una bomba al plutonio con l’intelligenza artificiale. “Dobbiamo democratizzare l’intelligenza artificiale e i dati sui quali si basa”, ha scritto Brad Smith, presidente di Microsoft, nel suo libro “Tools and Weapons”. Il 29 febbraio 2020, ha firmato a Roma un documento che vuole fare da battistrada. Si chiama “Call for an AI Ethics” e ha visto Microsoft e Ibm insieme a Fao, governo italiano e Pontificia accademia per la vita. Nasce la “algor-etica”, ovvero lo sviluppo e l’utilizzo dell’Ai secondo i principi di trasparenza, affidabilità, sicurezza e privacy, tra gli altri.
Alla fine della fiera, che fare? Bisogna davvero cancellare Facebook? E’ impossibile e sarebbe sbagliato. La piattaforma è una macchina per fare soldi, d’accordo. E allora, quando mai ha detto di essere una ong? Vive grazie alla pubblicità. E i giornali e le televisioni? La questione vera non riguarda il profitto, ma i profili degli utenti: li acquisisce gratis e li vende senza dare loro in cambio nemmeno un cent.
Si può spingere Zuckerberg sul sentiero che altri stanno imboccando, dal grande nemico Tim Cook, al mentore Bill Gates? Con gran candore Fances Haugen, davanti ai senatori ruggenti, ha detto che lei non vuol fare del male alla compagnia, ma vuole che cambi, che migliori, che recuperi lo slancio dei tempi migliori. Magari quelli nei quali non era ancora così direttamente preda dello scontro politico. Speranze ingenue. “La piattaforma è stata costruita per alimentare qualsiasi contenuto che scatenasse un’emozione, i suoi algoritmi favoriscono esplicitamente il sensazionalismo”, scrivono Sheera Frenkel e Cecilia Kang le due giornaliste del New York Times che nel 2018 hanno svelato le molteplici violazioni della privacy da parte di Facebook. Il loro libro, “An Ugly Truth”, una orribile verità, è stato tradotto con “Facebook: l’inchiesta finale” e appena pubblicato da Einaudi.
“Zuckerberg e Sandberg hanno costruito una inarrestabile macchina per fare soldi che potrebbe rivelarsi troppo potente da fermare. Anche se gli enti di controllo o lo stesso Zuckerberg decidessero un giorno di porre fine all’esperimento, la tecnologia che ci hanno scatenato contro non scomparirà con esso”. Sono nate altre piattaforme, e il Trump bandito le userà ancor meglio di come ha usato Facebook. Per non parlare dei russi e dei cinesi. Certo, hanno una diffusione minore, sono già etichettate, si rivolgono ai seguaci, a loro manca quella immagine di autonomia, di indipendenza, di agnosticismo persino alla quale Zuck non ha voluto rinunciare sapendo che era la sua forza. Adesso però è troppo tardi, il tempo è scaduto ha ragione il senatore Markey; non si torna al passato, ma dove si va? La domanda non ha risposta. Mark Zuckerberg rischia di restare come il tenente Hiroo Onoda l’ultimo giapponese nella giungla filippina sul quale ha scritto un libro il visionario regista tedesco Werner Herzog ed è stato girato un documentario presentato al festival di Cannes: per trent’anni vedeva passare gli aerei verso ovest, ma credeva che la guerra, la sua guerra, continuasse ancora su altri fronti.