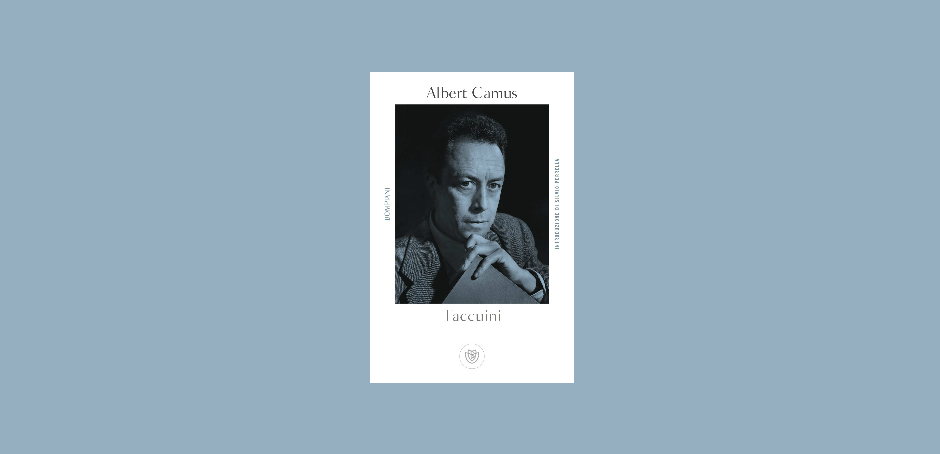Albert Camus (foto LaPresse)
Camus voleva essere un santo senza credere in Dio
“Tutto sommato, io ho da dire soltanto una cosa”, annota lo scrittore nei suoi Taccuini (Bompiani). Eppure occorre – e forse non basta – tutta una vita per dirla
“Tutto sommato, io ho da dire soltanto una cosa”, annota Camus nei suoi Taccuini (Bompiani). Eppure occorre – e forse non basta – tutta una vita per dirla. “Nel mio principio è la mia fine” scrisse Eliot, e nel leggere i primissimi appunti del ventiduenne franco-algerino è impressionante notare la chiarezza con cui metteva già a fuoco quanto cercherà di esprimere ancora e ancora: “Ciò che voglio dire: Che è possibile – senza degenerazioni romantiche – provare nostalgia per una povertà perduta. Un certo numero d’anni miseramente vissuti è sufficiente a costruire una sensibilità. In questo caso particolare quel curioso sentimento che il figlio prova nei confronti della madre costituisce tutta la sua sensibilità”.
Fino ai giorni che precedono l’incidente mortale, tanti anni e dolori dopo le nuotate del giovane tisico in amplesso con gli elementi, Camus farà sue le parole di un altro malato cronico, l’amato Nietzsche: “Nessuna sofferenza ha potuto, né potrà, indurmi a portare falsa testimonianza contro la vita, come io la conosco”. Anche lui è rimasto fedele alla terra, al mare, alla madre, al suo sorriso umiliato e sempre rinnovato, anche quando ciò ha chiesto di essere solo, incompreso persino dai compagni di lotta civile e culturale: “Non posso guarirmi dal mio cuore”.
Negli appunti si susseguono idee, citazioni, progetti, bozzetti, accenni di grandi cattedrali narrative e filosofiche, basamenti tracciati, strutture di opere effettivamente realizzate oppure percorsi mai compiuti, sguardi gettati dalla soglia. Una delle prime cose da imparare studiando è che non si deve sottolineare tutto, che ciò annulla il motivo stesso per cui si evidenzia qualcosa. Eppure, dinanzi a un susseguirsi di frasi come “Viviamo troppo a lungo” o “Lo scrittore è condannato alla comprensione”, di interrogativi e intuizioni che fondono Bloy e Pavese, di immagini come “La solitudine perfetta. Nell’orinatoio di una grande stazione all’una del mattino”, la tentazione è forte. Come si può recensire la storia di un’anima simile?
Ho sempre amato molto i diari, e gli epistolari. I quaderni di Simone Weil o Susan Sontag, le lettere di Cristina Campo a Leone Traverso. Rispetto al fiume fangoso di messaggi che assedia le nostre giornate, è specie di purificazione ricordarsi che certa gente sapeva scambiarsi dei diamanti. Hoffmansthal aveva raccolto un libro di citazioni personali e altrui, e l’aveva intitolato “Libro degli amici”; un’amicizia che è possibile e doveroso rivolgere anzitutto al dialogo con se stessi. C’è infatti una differenza profonda tra istintività e autenticità, quella “proprietà dei concetti e delle espressioni” come la definiva Leopardi e che proprio la fretta di comunicare ci fa trascurare. Rispetto allo sfacciato teatro di tanto diario collettivo, annotazioni come quelle di Camus colpiscono per la loro quasi imbarazzante esposizione, vulnerabilità. Un’auscultazione senza sconti, percorsa al contempo da un orgoglio che non è mai la fatua aggressività dei mediocri, ma la fierezza di chi ha continuato a suonare l’unica nota che conti: “Si dice che Nietzsche, dopo la rottura con Lou, approdato a una solitudine definitiva, passeggiasse di notte sulle montagne che dominano il golfo di Genova e vi accendesse immensi falò che guardava poi consumarsi. Ho pensato spesso a quei falò e il loro bagliore ha danzato dietro tutta la mia vita intellettuale. Se poi mi è capitato di essere ingiusto nei confronti di certi pensieri e di certi uomini che ho incontrato nel mondo, è perché, senza volerlo, li ho messi di fronte a quegli incendi e si sono subito ridotti in cenere”.
Nella sua dolorosa bellezza è un testo che si maneggia con difficoltà che verrebbe da definire sacrosanta, perché parole e immagini sono il distillato di una vita, e come tali vanno gustate goccia a goccia, contemplate lasciando che si posino in noi come una nave sul fondo del mare. Camus voleva essere santo senza credere in Dio, e questo è a tutti gli effetti un grande breviario col quale esercitarsi “a quella forma laica della preghiera che è l’attenzione” (Benjamin). Che il cuore di un altro uomo ci possa sottrarre al rullo tribale di tanti strepiti e pose e, al pari dei protagonisti della “Peste”, ci inviti a lasciare vestiti e ruoli alle spalle per nuotare insieme nel golfo notturno, un momento da uomo a uomo nelle acque scure, è uno dei grandi conforti di questa nostra vita: “Fra poco altre cose, e gli uomini, torneranno ad afferrarmi. Ma lasciatemi ritagliare questo minuto dalla stoffa del tempo, come altri lascerebbero un fiore fra le pagine per racchiudervi una passeggiata in cui li ha sfiorati l’amore. Anch’io passeggio, ma è un dio colui che mi accarezza. La vita è breve e perdere il proprio tempo è peccato. Io il mio tempo lo perdo continuamente, e gli altri mi credono estremamente attivo. Oggi, però, è una sosta, e il mio cuore muove incontro a se stesso”.


Il Foglio sportivo - in corpore sano
Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo