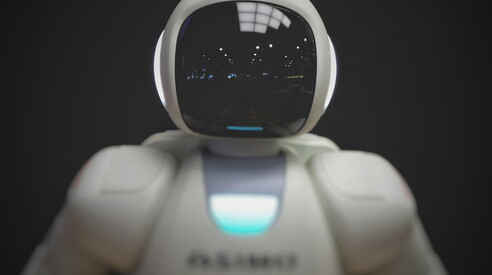Tim Cook alla Bocconi di Milano lo scorso novembre (foto LaPresse)
Le ipocrisie dell'attivista Tim Cook
Per i media e gli opinionisti di mezzo mondo la battaglia tra privacy e sicurezza intorno all’iPhone del terrorista di San Bernardino ha già un vincitore morale: il ceo di Apple Tim Cook, che con la sua lettera aperta in favore della privacy ha aggiunto una nuova voce al suo ricco curriculum di attivista per i diritti e le libertà civili. Sul New York Times di ieri, Katie Benner e Nicole Perlroth hanno tracciato il romanzo di formazione che ha portato Cook a diventare il paladino della trasparenza globale, collegando la disputa con l’Fbi con altri elementi della sua agiografia, come l’episodio celebre in cui, ragazzino dell’Alabama, si oppose alle violenze segregazioniste del Ku Klux Klan o l’ancor più celebre coming out. Ma per trasformarsi, come sta facendo Cook, nella coscienza liberal dell’occidente, serve una coerenza inflessibile, difficile da mantenere per il ceo di una compagnia quotata multimiliardaria. La posizione presa da Cook nella sua lettera “to our customers” è intransigente e non prevede compromessi, pena una “spaventosa” perdita di sicurezza per tutti gli utilizzatori di iPhone del mondo, ma la realtà inizia a mostrare che Apple, nel suo rapporto spesso travagliato con la giustizia americana, di compromessi ne ha fatti ben più di uno.
Shane Harris sul Daily Beast, per esempio, ha mostrato per primo i documenti di un caso giudiziario simile avvenuto a New York l’anno scorso, in cui Apple ha ammesso di aver sbloccato circa 70 iPhone su richiesta delle autorità dal 2008 a oggi. Il pezzo di Harris è stato criticato duramente, perché gli iPhone in questione erano modelli vecchi e meno pericolosi da sbloccare. Il problema, però, è che l’iPhone 5C del killer di San Bernardino appartiene esattamente a questa categoria, quella considerata dagli esperti relativamente facile da sbloccare. Il caso newyorchese, inoltre, mostra attraverso i documenti giudiziari come la preoccupazione principale di Apple davanti alle richieste di sblocco delle forze dell’ordine non fosse la sicurezza degli utenti quanto il timore di “danneggiare” il suo “brand”. Ecco la prima macchia sull’immacolato idealismo di Tim Cook.
A questo si aggiunga che iniziano a diffondersi commenti e studi credibili di hacker ed esperti di sicurezza secondo cui, al contrario di quanto scritto da Cook, estrarre informazioni dall’iPhone del killer di San Bernardino senza mettere in pericolo tutti gli altri iPhone, e dunque senza creare una “backdoor”, è tecnicamente possibile per Apple. Non serve nemmeno il genio pazzotico di John McAfee, ex mago degli antivirus e oggi autoproclamata “cybersecurity legend” coinvolta in diversi casi criminali, tra cui il traffico di droga, il quale ha promesso di sollevare Apple dalla terribile responsabilità di autohackerarsi sbloccando lui stesso l’impenetrabile iPhone in “tre settimane”.
Perfino il profilo agiografico del Nyt getta un’ombra sulla società quando rivela che nel caso di San Bernardino la società aveva chiesto all’Fbi di tenere segreta la richiesta di sblocco, e ha reagito con durezza solo quando i federali hanno reso tutto pubblico, mettendo a rischio la sua immagine aziendale. Nella gran disputa Apple-Fbi non ci sono i buoni, figuriamoci i santi.